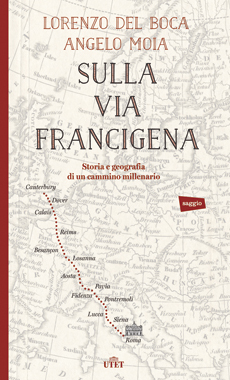ROMA – Un reportage di 28 articoli firmati da Tina Merlin e pubblicati sull’Unità non sono stati sufficienti per accendere qualche preoccupazione. Che la diga del Vajont fosse sicura e che non si potevano correre rischi lo accreditavano i vertici delle istituzioni, i municipi e tutti quegli ordinamenti cosiddetti intermedi che, sulle grandi opere, avevano un qualche ruolo di controllo.
Il primo articolo di denuncia fu pubblicato il 21 febbraio 1961, due anni e mezzo prima del disastro e per tutto quel periodo lei continuò a insistere per richiamare l’attenzione delle autorità. Inutile.
Risultato? Il 9 ottobre 1963 (56 anni fa) un angolo della valle del Piave precipitò nell’invaso idroelettrico arificiale. Come quando una fetta di pane viene lasciata cadere nel caffelatte, l’acqua raccolta schizzò e, scavalcando la diga, precipitò verso il fondovalle, travolgendo e distruggendo tutto quello che incontrava.
Spaventosi i numeri del disastro. Il monte Toc lasciò cadere 270 milioni di metri cubi di materiale. La frana raggiunse la velocità di 108 chilometri l’ora. L’invaso conteneva 115 milioni di metri cubi d’acqua dei quali almeno 30 milioni arrivarono a travolgere i paesi che stavano sotto.
Longarone, Erto, Cassio, Pirago, Castavallazzo e Codissago vennero cancellati da onde che, all’origine, toccarono i 250 metri d’altezza.
I campanili dei villaggi avevano appena battuto il mezzo tocco dopo le dieci. I resoconti giudiziari riuscirono a essere anche più precisi: erano le 22 e 39. Bastarono due minuti per dare corpo a una tragedia di proporzioni bibliche.
Quando quello tsunami d’acqua si placò, la valle era diventata una pozza d’acqua larga 30 chilometri quadrati. Tutto dello stesso colore del fango che aveva coperto ogni forma e seppellito 1.917 persone. I sopravvissuti non riuscirono mai a spiegare per davvero come avevano potuto salvarsi in mezzo a quel disastro.
Quella fu (se non proprio la prima) la più grave delle cosiddette “tragedie annunciate”. E a lanciare l’allarme furono proprio le pagine dei giornali.
Tina Merlin, corrispondente per il Tri-Veneto del quotidiano dell’allora Partito Comunista, aveva fatto il suo mestiere. Interviste, confronti, verifiche, lavoro “sul campo” e lavoro “a tavolino” studiando i progetti.
L’Unità, allora, era un giornale schierato ideologicamente ma chi ci lavorava, specialmente nelle redazioni di cronaca, il mestiere lo faceva seriamente e senza pregiudizi.
Tina Merlin era comunista fino al midollo. Negli anni della fine della guerra, aveva affiancato i partigiani nella lotta per la liberazione tanto che la sua iscrizione al Pci e l’assunzione nel giornale del partito erano sembrati un approdo naturale. Lei partecipava alle campagne elettorali con foga e determinazioni. La si sarebbe detta una “pasionaria rossa”. Ma, dovendo rivolgersi ai lettori del giornale, anche se politicamente schierati, manteneva quell’equilibrio doveroso per chi si occupa d’informazione.
A proposito della diga del Vajont era impossibile non accorgersi che il progetto era diventato ingestibile e, quindi, pericoloso.
La diga venne realizzata nonostante e contro le evidenze che ne avrebbero sconsigliato la costruzione. I progettisti non considerarono sufficientemente le caratteristiche morfologiche del territorio troppo friabile e, quindi, poco adatto a ospitare impianti di grandi dimensioni.
Il fatto che la montagna interessata si chiamasse Toc che, nel nome, denunciava la fragilità della sua struttura, già avrebbe dovuto rappresentare un campanello d’allarme.
Invece gli enti interessati, a cominciare dai Municipi, s’industriarono per minimizzare o, addirittura, nascondere le criticità che si andavano manifestando. In quelle zone, flagellate dalla miseria, sembrava che, con l’industria, dovesse arrivare anche un briciolo di consistenza economica. Cemento come progresso.
Gli è che gli impianti andarono crescendo a dismisura. La prima concessione riguardò una diga “a doppio arco” di 202 metri, capace di contenere 58 milioni di metri cubi. L’impianto definitivo arrivò a costruire fino a 725 metri utili per un invaso di 660 milioni di metri cubi.
Perché passassero i camion con i materiali, fu necessario allargare un sentiero e trasformarlo in una vera e propria strada. E, a ogni passaggio, un colpo alla traballante equilibrio della montagna.
 Tina Merlin se ne era accorta e lo aveva denunciato. Fu denunciata, rimediando un’imputazione per “diffusione di notizie false e tendenziose” con l’aggravante che si trattava di informazioni “atte a turbare l’ordine pubblico”. A Milano, il processo si concluse con la sua assoluzione. Ma se il suo lavoro di giornalista era stato corretto perché non crederle? Perché non prendere in considerazione le sue denunce? (giornalistitalia.it)
Tina Merlin se ne era accorta e lo aveva denunciato. Fu denunciata, rimediando un’imputazione per “diffusione di notizie false e tendenziose” con l’aggravante che si trattava di informazioni “atte a turbare l’ordine pubblico”. A Milano, il processo si concluse con la sua assoluzione. Ma se il suo lavoro di giornalista era stato corretto perché non crederle? Perché non prendere in considerazione le sue denunce? (giornalistitalia.it)












 CONVENZIONI
CONVENZIONI