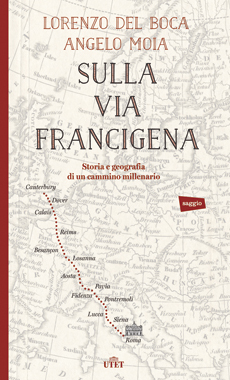ROMA – Per la Cassazione non erano diffamatori una serie di servizi mandati in onda 15 anni fa da tre giornalisti su due telegiornali di Rti, cioè Rete 4 – all’epoca diretto da Emilio Fede – e Italia 1. Sono state, così, definitivamente respinte le richieste di risarcimento avanzate dall’allora magistrato del Tribunale di Vibo Valentia, Michele Sirgiovanni, che é stato anche condannato a rifondere le spese legali sostenute dai giornalisti Giandomenico Curtò, Alessandra Magliani, Roberta Mani, che sono stati tutti scagionati da qualsiasi responsabilità civile perché non divulgarono il nome del magistrato, né esistevano altri elementi che consentissero di individuarlo con certezza. (giornalistitalia.it)
ROMA – Per la Cassazione non erano diffamatori una serie di servizi mandati in onda 15 anni fa da tre giornalisti su due telegiornali di Rti, cioè Rete 4 – all’epoca diretto da Emilio Fede – e Italia 1. Sono state, così, definitivamente respinte le richieste di risarcimento avanzate dall’allora magistrato del Tribunale di Vibo Valentia, Michele Sirgiovanni, che é stato anche condannato a rifondere le spese legali sostenute dai giornalisti Giandomenico Curtò, Alessandra Magliani, Roberta Mani, che sono stati tutti scagionati da qualsiasi responsabilità civile perché non divulgarono il nome del magistrato, né esistevano altri elementi che consentissero di individuarlo con certezza. (giornalistitalia.it)
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Cassazione Sezione SESTA CIVILE
Ordinanza n. 3015 del 9 febbraio 2021
udienza del 12 novembre 2020 (Presidente Chiara Graziosi, Relatore Marco Rossetti)
ORDINANZA
sul ricorso 29742-2018 proposto da:
Sirgiovanni Michele, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi, 6, presso lo studio dell’avvocato Federico Lucarelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Scuticchio e Pietro Proto per procura allegata al ricorso;
– ricorrente
contro
Curtò Giandomenico, Magliani Alessandra, Mani Roberta, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio dell’avvocato Carla Previti, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Salvatore Pino per procura in calce al controricorso;
controricorrenti –
nonché Reti Televisive Italiane – Rti spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Fede Emilio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone 60 presso lo studio dell’avvocato Stefano Previti, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1453/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 6 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 Michele Sirgiovanni convenne dinanzi al Tribunale di Roma Giandomenico Curtò, Alessandra Magliani, Emilio Fede, Roberta Mani e la RTI s.p.a., esponendo quanto segue:
-) di essere un magistrato, e di avere esercitato le proprie funzioni nel 2006 nel Tribunale di Vibo Valentia;
 -) il 10 novembre 2006 il notiziario diffuso dalla emittente televisiva “Retequattro”, di proprietà della società convenuta, in un servizio curato dal giornalista Giandomenico Curtò, riferì di una operazione di polizia che aveva condotto all’arresto di un magistrato del Tribunale di Vibo Valentia, Patrizia Pasquin, ed aggiunse che nell’inchiesta “sarebbero coinvolti altri due magistrati che, secondo fonti investigative, collaboravano assiduamente con la Pasquin”;
-) il 10 novembre 2006 il notiziario diffuso dalla emittente televisiva “Retequattro”, di proprietà della società convenuta, in un servizio curato dal giornalista Giandomenico Curtò, riferì di una operazione di polizia che aveva condotto all’arresto di un magistrato del Tribunale di Vibo Valentia, Patrizia Pasquin, ed aggiunse che nell’inchiesta “sarebbero coinvolti altri due magistrati che, secondo fonti investigative, collaboravano assiduamente con la Pasquin”;
-) la notizia venne ribadita in un notiziario del giorno successivo, in un servizio curato dalla giornalista Sandra Magliani, nel quale si riferiva che l’indagine suddetta avrebbe accertato l’esistenza di un comitato d’affari colluso con una organizzazione criminale della quale avrebbero fatto parte, oltre la suddetta Patrizia Pasquin, anche “due magistrati”;
-) notizie analoghe vennero riferite il 10 novembre 2006 da un’altra emittente televisiva, pure di proprietà della società convenuta, l’emittente “Italia 1”, in un servizio curato dalla giornalista Roberta Mani;
-) le suddette notizie avevano leso l’onore e la reputazione dell’attore.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito in conseguenza dei fatti sopra descritti.
 2. Si costituirono tutti i convenuti ad eccezione di Roberta Mani. Con ordinanza 21 settembre 2011 n. 12675, pronunciata ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., il Tribunale di Roma rigettò la domanda compensando le spese. Ritenne il Tribunale che le notizie riferite dai giornalisti convenuti non consentivano di individuare con certezza la persona dell’attore. La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Si costituirono tutti i convenuti ad eccezione di Roberta Mani. Con ordinanza 21 settembre 2011 n. 12675, pronunciata ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., il Tribunale di Roma rigettò la domanda compensando le spese. Ritenne il Tribunale che le notizie riferite dai giornalisti convenuti non consentivano di individuare con certezza la persona dell’attore. La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. Con sentenza 6 marzo 2018 n. 1453 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, condannando l’appellante alle spese. Ritenne la Corte d’appello che:
-) le trasmissioni ritenute diffamatorie avevano dato conto di una indagine che aveva condotto all’arresto di un magistrato, e allo svolgimento di indagini nei confronti di altri magistrati; tali notizie erano esatte;
-) le notizie per come riferite dai due telegiornali sopra indicati non potevano in alcun modo consentire all’utente medio di associare l’attore ai fatti in esse riferiti, dal momento che di questi innominati “altri magistrati” indagati non si riferiva il nome; non si riferiva che funzioni svolgessero; non si riferiva nemmeno la loro sede lavorativa;
-) in ogni caso le notizie riferite erano oggettivamente vere, dal momento che Michele Sirgiovanni all’epoca dei fatti era ufficialmente indagato; la circostanza che fosse indagato per abuso d’ufficio, invece che per truffa e corruzione, come riferito dai telegiornali, era circostanza irrilevante, alla luce della impossibilità della sua identificazione, per quanto già detto.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Michele Sirgiovanni con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi da un lato Giandomenico Curtò, Alessandra Magliani e Roberta Mani; dall’altro la RTI S.p.A. ed Emilio Fede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione di sette diverse norme di legge, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che le trasmissioni diffamatorie non consentissero l’individuazione della persona dell’attore. Deduce che la decisione sarebbe incoerente col principio di diritto affermato da una sentenza di questa Corte, la sentenza 26 ottobre 2017 n. 25420, e cioè quello secondo cui una notizia deve ritenersi diffamatoria anche quando, pur non nominando la persona diffamata, l’identità di questa possa essere desunta aliunde dal lettore o dall’ascoltatore medio.
Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, “gli elementi individuanti i due magistrati [diffamati] nelle persone di Sirgiovanni e Romano e la sede giudiziaria sono riscontrabili negli stessi servizi di telegiornale effettuati dai resistenti”; deduce che la riferibilità delle notizie all’odierno ricorrente doveva essere valutata anche in base alle altre notizie, contemporaneamente diffuse da altri telegiornali ed organi di stampa, nei quali espressamente si faceva il nome di Michele Sirgiovanni; che in sostanza – questo il cuore della censura – la Corte d’appello non avrebbe considerato che il pubblico, già edotto da altre fonti di informazione sull’indagine a carico di Michele Sirgiovanni, ascoltando anche il telegiornale trasmesso dalle emittente “Retequattro” ed “Italia 1”, avrebbe potuto facilmente associare alla persona dell’odierno ricorrente le notizie ivi riferite.
A questa censura ne segue una seconda, alquanto oscura, secondo cui poiché l’odierno ricorrente aveva chiesto al Garante della privacy il diritto di accesso (il ricorso non riferisce chiaramente a quali atti), e tale accesso gli era stato accordato, ciò dimostrerebbe ex se “la titolarità della situazione sostanziale” (il ricorso tuttavia non precisa in modo chiaro a quale “situazione sostanziale” abbia inteso fare riferimento).
1.1. Il motivo è inammissibile. Stabilire se un servizio giornalistico che si assume diffamatorio consenta o non consenta di attribuire i fatti riferiti ad una determinata persona è un tipico accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. Lo ha affermato proprio la sentenza “capostipite” dell’orientamento invocato dal ricorrente, e cioè Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 6 agosto 2007. Quella sentenza non ha affatto affermato quel che il ricorrente pretende di farle dire, e cioè che una notizia è sempre diffamatoria quando, pur non riportando le generalità del diffamato, queste ultime siano riferite da altre e contemporanee notizie televisive o di stampa.
La sentenza 17180/07 ha affermato un principio ben diverso, così riassumibile: a) in iure, la circostanza che la notizia diffamatoria non faccia nomi non è di per sé idonea ad escluderne l’offensività; b) in facto, lo stabilire se le generalità del diffamato, pur non riferite nella notizia diffamatoria, potessero essere nel caso di specie desumibili aliunde, è “una questione di fatto (..) inammissibile in (…) sede” di legittimità (così la sentenza 17180/07, 5 1.1 dei “Motivi della decisione”).
1.2. Lo stesso principio è stato affermato in altre decisioni di questa Corte che hanno dato continuità a questo orientamento, ed in particolare:
-) Sez. 3, Sentenza n. 16543 del 28 settembre 2012, la quale dopo avere ribadito i principi di cui sopra, ha affermato che la censura con cui il ricorrente intendeva sostenere che la sua persona era identificabile dal contesto oggettivo “si risolveva in una sollecitazione, rivolta a questa Corte, ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio acquisito”;
-) Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 27 agosto 2015, la quale – decidendo identica controversia, promossa proprio dall’odierno ricorrente nei confronti di una emittente radiofonica – ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di risarcimento. Ivi si è affermato che correttamente il giudice di merito aveva escluso la responsabilità dei giornalisti e dell’emittente convenuti, in quanto “in nessuno dei due comunicati si [è] fatto cenno non solo alle sue generalità od a caratteristiche personali, ma nemmeno al sesso, alle mansioni specifiche nell’ambito dell’ufficio giudiziario (…), alla residenza, alla famiglia o ad altri elementi precisi ed inequivocabilmente a lui riferibili, che ne consentissero un’immediata identificazione”.
Nella sentenza appena ricordata, inoltre, nel par. 5 3.1 dei “Motivi della decisione” si afferma: “ciò che rileva [ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria] è se la notizia inesatta potesse essere riferita con certezza al dott. Michele Sirgiovanni, così come percepita dagli ascoltatori radiofonici, in base al contesto, anche temporale, in cui venne ad inserirsi. In proposito, il ricorrente chiede a questa Corte di delibare se, in questo contesto, debbano essere considerati anche i riferimenti personali e le circostanze riferite da altre fonti informative che si siano occupate della medesima vicenda di cronaca [una censura, dunque, identica a quella oggi in esame: n.d.e.]. (…)”.
Detto ciò, è vero quanto sostenuto dai resistenti secondo cui la questione posta dal primo motivo non involge tanto profili di diritto quanto “profili di fatto”. Tutti questi princìpi, nel caso di specie, sono stati rispettati dalla Corte d’appello: quest’ultima, infatti, non ha affatto affermato in modo assiomatico che, poiché i due telegiornali non avevano riferito il nome del dott. Michele Sirgiovanni, per ciò solo non erano diffamatòri. Ha affermato invece un principio ben diverso: e cioè che i due telegiornali non solo non divulgarono il nome dell’odierno ricorrente, ma nemmeno esistevano altri elementi che consentissero di individuarlo con certezza (così la sentenza impugnata, pagine 13-14). E quest’ultima, per quanto detto, è una valutazione di fatto insindacabile in questa sede.
2. Col secondo motivo (numerato come “1B”, p. 19 del ricorso) il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1362, 1363, 1365 e 1368 c.c.; nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di “valutare i comportamenti anche posteriori delle parti (…) ai fini della individuazione del ricorrente dott. Michele Sirgiovanni come soggetto passivo della diffamazione”.
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello non ha violato le norme sulla interpretazione dei contratti, per la semplice ragione che di quelle norme non doveva fare applicazione. Essa infatti non doveva interpretare alcun contratto, ma solo accertare un fatto illecito. Ove, poi, benevolmente, si volesse qualificare il motivo ex officio come censura del giudizio di “non individuabilità” della persona che si assume in tesi diffamata, esso sarebbe inammissibile per le ragioni già esposte: e cioè che è rivolto contro un apprezzamento di fatto.
3. Il terzo motivo (contraddistinto dal n. 2: p. 20 del ricorso) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il riferire che una persona sia indagata per corruzione, invece che per abuso d’ufficio, sarebbe una circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità civile per lesione dell’onore e della reputazione.
3.1. Il motivo è inammissibile. L’affermazione censurata dal motivo in esame è stata infatti compiuta dalla Corte d’appello solo ad abundantiam. La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul rilievo che i fatti riferiti dalle testate edite dalla società convenuta non potessero essere riferiti con certezza dagli ascoltatori all’odierno ricorrente. Tale giudizio rendeva di conseguenza superfluo accertare se quei fatti fossero veri, veritieri, veridici o falsi.
4. Col quarto motivo (contraddistinto dal n. 3: p. 22 del ricorso) il ricorrente impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese del grado di appello. Lamenta la violazione dell’articolo 4 d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe commesso i seguenti errori:
a) non ha adeguatamente tenuto conto della natura delle questioni trattate;
b) non ha tenuto conto del rigetto delle eccezioni preliminari di rito sollevate dagli appellanti, odierni controricorrenti;
c) non ha tenuto conto che quando la parte vittoriosa è assistita da più avvocati la liquidazione a carico del soccombente va computata per un solo avvocato;
d) ha liquidato a titolo di spese alla sola Roberta Mani un importo “incomprensibile”.
4.1. La censura indicata sub (a) al § che precede è inammissibile in quanto lo stabilire se la materia oggetto del contendere giustifichi o meno, ed in che misura, una variazione dell’importo tabellare previsto dal d.m. 55/14, piuttosto che la compensazione delle spese, costituisce un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
4.2. La censura sub (b) è infondata: infatti la “soccombenza” che giustifica la condanna alle spese va riferita all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (ex multis, Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18503 del 2 settembre 2014, Rv. 632108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 5 aprile 2003, Rv. 561926 – 01).
4.3. La censura sub (c) è infondata. In appello assunsero la veste di “appellati” cinque parti:
-) Giandomenico Curtò, Alessandra Maglioni e Roberta Mani, tutti e tre col ministero degli avvocati Salvatore Pino e Carla Previti;
-) Emilio Fede e la RTI s.p.a., tutti e due col ministero degli avvocati Daniele Franzini e Stefano Previti.
4.4. Emilio Fede e la RTI erano due parti assistite da due avvocati: ad essi spettava quindi il compenso previsto per un solo avvocato (art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/14), maggiorato del 30% per ogni parte oltre la prima (art. 4, comma 2, d.m. 55/14). La Corte d’appello ha liquidato complessivamente ai due soggetti suddetti euro 9.678 (e cioè 4.839 pro capite). Ma il compenso “tabellare” ex art. 4 d.m. 55/14 per le cause in grado di appello, di valore indeterminato e di complessità media (quale deve ritenersi la presente) è pari ad euro 8.066, che maggiorato del 30% ed al netto del compenso per l’istruttoria (che in appello non si è svolta) sale ad euro 10.485. La Corte d’appello ha dunque compiuto una liquidazione addirittura inferiore ai valori medi.
4.4.1. Alla luce delle conclusioni che precedono, non possono condividersi le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.. Il ricorrente osserva–- correttamente – che all’avvocato il quale assista più parti, risultate vittoriose all’esito del giudizio, spetta a carico del soccombente un solo compenso, maggiorato nella misura stabilita dalla legge. Ne trae la conclusione che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 4, comma 2, d.m. 55/14 per avere separatamente liquidato una somma a titolo di spese a ciascuna delle parti vittoriose. Tuttavia quel che rileva ai fini della illegittimità della liquidazione delle spese non è lo stabilire se il giudice di merito abbia o non abbia frazionato fra i litiganti assistiti dal medesimo avvocato il compenso globale ad essi dovuto; quel che rileva è soltanto se tale compenso globale abbia o non abbia ecceduto i parametri massimi di legge: e, per quanto detto, nel caso di specie tale eccedenza non si è verificata.
4.5. Giandomenico Curtò, Alessandra Magliani e Roberta Mani erano anch’essi difesi in appello da due avvocati. Roberta Mani tuttavia aveva una posizione parzialmente diversa dagli altri due, perché in appello eccepì la nullità del giudizio di primo grado per difetto di notifica. La Corte d’appello ha liquidato complessivamente a tutti e tre i suddetti appellati 17.744 euro. Il compenso massimo tabellare previsto per le cause di valore indeterminato in appello è 14.158, compenso che nella specie si sarebbe dovuto maggiorare del 60% (e cioè del 30% per ogni parte oltre la prima: art. 2, comma 2, d.m. 55/14). Il risultato è 22.652,8. La Corte d’appello pertanto, liquidando la minor somma di euro 17.744 per i tre appellati suddetti, ha compiuto una liquidazione inferiore al massimo tabellare e perciò non illegittima. Lo stabilire poi se fosse adeguata nel caso di specie al pregio dell’opera svolta dai difensori è una valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede.
4.5. La censura sub (d) resta assorbita da quanto esposto. Ed infatti, una volta stabilito che l’importo delle spese complessivamente liquidato al gruppo “Curtò-Magliani-Mani” non superò il massimo tabellare, il ricorrente non ha interesse – ex art. 100 c.p.c. – a dolersi della ripartizione, tra i vari appellati, delle spese ad essi complessivamente dovute.
5. Col quinto motivo (contraddistinto dal n. 4: p. 24 del ricorso) il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione circa la determinazione dei compensi che precedono.
5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti, essendo la statuizione sulle spese conforme a diritto, è irrilevante la circostanza dell’eventuale mancanza di motivazione, la quale può venire in rilievo unicamente con riferimento agli accertamenti di fatto. In ogni caso il motivo è infondato perché la motivazione non manca, avendo la Corte d’appello dichiarato di liquidare le spese tenendo conto “della natura della causa, del livello di complessità delle questioni proposte, dell’attività svolta dalla parte vittoriosa, della difesa congiunta di più soggetti da parte dei loro difensori, ad eccezione della signora Mani”.
6. Il sesto motivo (contraddistinto dal n. 5: p. 24 del ricorso) è intitolato “omesso esame d’un fatto decisivo”. Ad onta di tale intitolazione, nella illustrazione del motivo si sostiene che la motivazione della sentenza contiene argomenti “privi di collegamento e/o concatencnione logica e teleologica tra la base originaria del discorso ed il suo senso compiuto”; si aggiunge che la sentenza è “totalmente priva di ragionamenti argomentativi e che non spiega il perché della propria decisione”.
6.1. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata non manca ed è ben chiara: e cioè che i due telegiornali non avevano contenuto diffamatorio, perché non consentivano al pubblico di comprendere chi fossero gli “altri magistrati” accusati di corruzione. La Corte d’appello ha spiegato che la notizia diffusa dalle due emittenti non consentiva l’individuazione dei suddetti magistrati perché non riferiva né il loro nome, né il loro luogo di lavoro, né le loro funzioni. La motivazione dunque non manca; lo stabilire poi se nel caso di specie la persona dell’odierno ricorrente fosse davvero individuabile o non individuabile nel caso concreto è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nella liquidazione di esse si è tenuto conto:
– che il valore della causa era indeterminabile;
– che la complessità del presente ricorso per cassazione, ai fini della liquidazione dei compensi, è da reputare “bassa”, attesa la manifesta inammissibilità del ricorso;
– dell’aumento del 30% per la difesa di più parti oltre la prima, ex art. 4, comma 2. d.m. 55/14.
7.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Michele Sirgiovanni alla rifusione in favore di Giandomenico Curtò, Roberta Mani e Alessandra Magliani, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente nella somma di euro 3.350, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna Michele Sirgiovanni alla rifusione in favore di Giandomenico Curtò, Roberta Mani e Alessandra Magliani, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente nella somma di euro 3.350, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di Michele Sirgiovanni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. (giornalistitalia.it)






















 CONVENZIONI
CONVENZIONI