ROMA – I giornali non sono gli articoli che pubblicano, sono qualcosa di più. Repubblica non sono i pezzi di Eugenio Scalfari, di Bernardo Valli ieri e di Gustavo Zagrebelsky oggi. Il Corriere della Sera non è Indro Montanelli ieri, Ferruccio de Bortoli e Gian Antonio Stella oggi. Non è neppure i suoi premi Nobel come Eugenio Montale o le sue glorie letterarie come Dino Buzzati. Il manifesto non è mai stato solo gli articoli di Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Luciana Castellina e Valentino Parlato. No, i giornali sono idee, passione, ideologia (oltre che interessi). L’unica cosa certa in un quotidiano non è il direttore responsabile, ma il fatto che quelle 16, 24 o 48 pagine formano un organizzatore collettivo, uno strumento che nasce e vive per incidere nella società che lo circonda. Questo è il motivo per cui il cosiddetto smart working non ha nulla di “smart” ed è un altro passo verso la fine dei giornali così come li abbiamo conosciuti negli ultimi due secoli.
I giornali non sono uffici del catasto e nemmeno ministeri: benché negli ultimi anni siano diventati fortemente centralizzati dal punto di vista editoriale e fortemente dipendenti dall’editore e dai suoi interessi, palesi o più spesso occulti, rimangono imprese bizzarramente artigianali e per questo spazi di libertà (inutile chiedere a un giornalista un articolo che non vuole scrivere: ne verrà fuori un pasticcio impubblicabile).
Questi spazi di libertà, però, hanno da essere collettivi: nessuno ha mai fatto un buon giornale rinchiudendo i redattori nelle loro stanzette o nei deprimenti open space che le follie manageriali hanno imposto una trentina d’anni fa, men che meno nel cosiddetto smart working di cui si parla oggi. E l’unico momento veramente collettivo di una redazione è la riunione del mattino, una riunione che nei brutti giornali (la maggioranza) è fatta dai soli capiredattori e capiservizio mentre nei bei giornali riunisce tutti, anche i neoassunti che per anni non osano aprire bocca di fronte al Direttore.
Mi dicono che Repubblica nacque così, con affollate riunioni di redazione che iniziavano alle 10 del mattino e duravano più di due ore, nella disperazione dei capiservizio che dovevano andare a organizzare le pagine (nel 1976 non esisteva WhatsApp e nemmeno i telefonini). Mi limiterò quindi a parlare della riunione del manifesto, di cui ho esperienza diretta, che iniziava verso mezzogiorno e aveva durata incerta: interminabile quando c’erano questioni politiche scottanti, relativamente breve quando il tema della giornata era chiaro e si trattava soltanto di decidere come affrontarlo e cos’altro mettere nelle pagine (che erano poche: grazie al genio grafico di Giuseppe Trevisani il giornale nacque con sole 4 pagine fitte e senza foto, non c’era spazio per le frivolezze).
La riunione si teneva al quinto piano di via Tomacelli 146, in una stanza troppo piccola e invasa dal fumo delle gauloises di Valentino Parlato e dei sigari di vari altri tabagisti. Era il regno dei capiredattori Luca Trevisani e Michele Melillo, che venivano dall’Unità e sapevano come far funzionare la macchina. Tutti partecipavano: i fondatori, e tutti i “giovani”, cioè un gruppetto di entusiasti la cui unica esperienza precedente erano i volantini davanti alle scuole o alle fabbriche, oltre ai tecnici, tipografi e fattorini alla pari con gli altri (anche gli stipendi erano rigorosamente uguali per tutti).
Al contrario di Scalfari, alle riunioni Pintor parlava poco, quasi solo se richiesto, ma naturalmente veniva ascoltato come se fosse il Messia per la lucidità delle sue analisi e la brevità dei suoi interventi, del resto coerente con la precisione dei suoi editoriali (mai più di 60 righe). Se Rossanda era intoccabile e Castellina ascoltatissima perché la più “giornalista” del gruppo, Luigi Pintor era adorato per la sua umiltà; di solito lasciava la riunione dicendo: “Scrivo, ma se non va bene metteteci qualcos’altro” (naturalmente non è mai successo che andasse in pagina qualcos’altro).
Le riunioni erano un formidabile strumento di motivazione dei giovani e mal pagati redattori, o dei collaboratori che non erano pagati affatto ma si nutrivano della vicinanza con persone che avevano letto tutto, visto tutto, conosciuto tutti. Rossanda era stata una delle poche persone ascoltate da Togliatti, Pintor aveva fatto la resistenza a Roma e diretto l’Unità, Valentino Parlato frequentava la Banca d’Italia con la stessa disinvoltura con cui scendeva a bere un whisky al Bar Antille. Il compagno di Rossanda, Karol S. Karol, era un polacco che aveva perso un occhio combattendo contro i nazisti, conosceva Mao e Fidel Castro, mandava reportage dai quattro angoli del mondo. In quale altro luogo i giovanissimi veneziani, torinesi o napoletani avrebbero potuto fare esperienze comparabili? Questo è il motivo per cui il “manifesto” degli anni Settanta-Ottanta ha prodotto una quantità di giornalisti che sarebbero diventati molto noti una ventina d’anni dopo, a cominciare da Lucia Annunziata presidente della Rai e Gad Lerner (che però rimase poco tempo in via Tomacelli) insieme a moltissimi altri.

Riunione di redazione de La Stampa al Lingotto di Torino, nel 2018, con l’allora direttore Maurizio Molinari, e l’intervento dell’editore John Elkan
La riunione di redazione aveva, naturalmente, anche i suoi inconvenienti. Uno era il politicismo, la distanza siderale che contribuiva a creare con le realtà italiane fuori Roma: malgrado il culto delle lotte operaie e la celebrazione dei movimenti di liberazione il giornale non riuscì mai a dare uno spazio adeguato ai militanti che facevano riferimento ad esso a Milano, a Napoli, a Marghera o a Taranto. Un secondo problema era la rigidità che creava in un quotidiano che doveva “chiudere presto” per arrivare in Sicilia, in Sardegna o in Friuli. Se il pomeriggio succedeva qualcosa di non previsto Michele Melillo, il caporedattore siciliano che aveva il controllo delle pagine, detestava cambiare il menabò, fosse pure per l’eruzione del vulcano Krakatoa.
 Molti anni dopo, con l’aumento della foliazione e il cambio di formato, si creò un altro momento collettivo di condivisione e creatività, alle 19, poco dopo l’inizio del Tg3: la prima pagina con una grande foto a colori e un titolo-sberleffo. La routine e la pigrizia sono sempre in agguato nei giornali: fare ogni giorno qualcosa di originale è difficilissimo, lo si vede dal grigiore dei quotidiani di oggi. Al manifesto la prova viene quotidianamente superata in scioltezza, con vertici insuperabili: la foto di Joseph Ratzinger eletto Papa con il titolo “Il pastore tedesco” (20 aprile 2005). Oppure la prima pagina con Barack Obama presidente degli Stati Uniti: “Indovina chi viene a cena”, (6 novembre 2008). Mentre quando Telecom fu venduta agli spagnoli il giornale pubblicò l’immagine di una cabina telefonica in un paesaggio desolato con il titolo “È caduta la linea” (25 settembre 2012).
Molti anni dopo, con l’aumento della foliazione e il cambio di formato, si creò un altro momento collettivo di condivisione e creatività, alle 19, poco dopo l’inizio del Tg3: la prima pagina con una grande foto a colori e un titolo-sberleffo. La routine e la pigrizia sono sempre in agguato nei giornali: fare ogni giorno qualcosa di originale è difficilissimo, lo si vede dal grigiore dei quotidiani di oggi. Al manifesto la prova viene quotidianamente superata in scioltezza, con vertici insuperabili: la foto di Joseph Ratzinger eletto Papa con il titolo “Il pastore tedesco” (20 aprile 2005). Oppure la prima pagina con Barack Obama presidente degli Stati Uniti: “Indovina chi viene a cena”, (6 novembre 2008). Mentre quando Telecom fu venduta agli spagnoli il giornale pubblicò l’immagine di una cabina telefonica in un paesaggio desolato con il titolo “È caduta la linea” (25 settembre 2012).
Ma non si creda che con il passare degli anni la verve della redazione diminuisca: il ministro degli Esteri Alfano viene onorato di una foto mentre fa le smorfie insieme al titolo “Il ministrello” (17 luglio 2013), la morte di Margherita Hack viene raccontata con un “Stella rossa” sopra la sua foto (28 giugno 2012) mentre il problema dello smaltimento della plastica viene affrontato dal supplemento settimanale l’Extraterrestre con il titolo “I pannolini sporchi si lavano in famiglia” (20 febbraio 2020).
Sopravvivrà tutto questo al cosiddetto smart working? (giornalistitalia.it)
Fabrizio Tonello







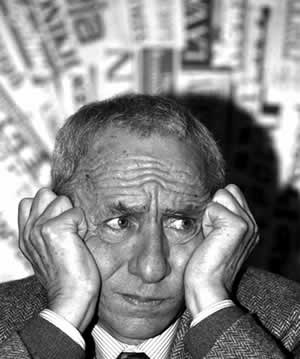





 CONVENZIONI
CONVENZIONI
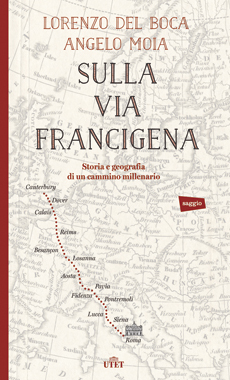


Bello quanto avvincente…e,soprattutto, manca…