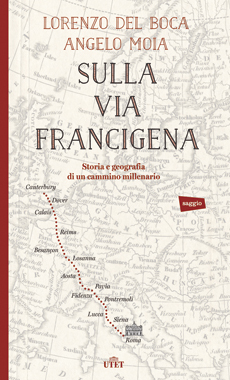PALERMO – Di Leonardo Sciascia, il massimo autore civile italiano del Novecento, morto trent’anni fa, il 20 novembre del 1989, restano i libri. Ma restano anche migliaia di articoli tra giornali e riviste perché nessuno come lui fu uno scrittore da prima pagina.
Con un intento dichiarato, come disse durante un’intervista alla Rai: “E’ un atto di fondamentale ottimismo quello di scrivere. Di continuare a scrivere, dando ragguaglio di una realtà così terribile, in un certo senso denunciandola. Certo, l’esperienza non consiglia eccessivo ottimismo”.
Tutta la sua opera si inanella intorno alla ricerca della verità contro menzogne e pregiudizi, intorno al “rispetto della verità sostanziale dei fatti” che solo l’uso della ragione può fare emergere tra controversie e contraddizioni. E soprattutto intorno al problema della giustizia, il “problema” per eccellenza “perché ingloba quello della libertà, e della dignità, e del rispetto tra uomo e uomo”.
Già nel 1956, ancora maestro elementare a Racalmuto, paese di miseria e zolfo nella Sicilia più arida, vicino ad Agrigento, Sciascia affermava: “Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono… Ho tentato di raccontare qualcosa della vita di un paese che amo, e spero di aver dato il senso di quanto lontana sia questa vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione. La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse – un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso”.
E aggiungeva: “Certo, un po’ di fede nelle cose scritte ce l’ho anch’io”.
Una fede eretica che anni dopo Sciascia definiva una scelta di “religioso eroismo” perché come Pirandello: “La vita o la si vive o la si scrive”. Per cui l’uso consapevole delle parole. Le parole come pietre. Macigni per il peso che ciascuna di loro può assumere nel contesto.
Un romanzo quotidiano, quello di Leonardo Sciascia, in cui la presenza nei giornali fu preludio dell’opera narrativa. Perché la vicenda di Sciascia scrittore ebbe inizio nel 1944 con la collaborazione alle pagine di alcuni fogli siciliani. Un interesse precoce – aveva poco più di vent’anni – anteriore alla pubblicazione nel 1950 del formidabile libro di esordio: “Favole della dittatura”.
 Dagli anni Quaranta in poi, se si mettessero in fila tutti gli articoli dello scrittore siciliano, si potrebbero ripercorrere le tappe degli avvenimenti della Prima Repubblica.
Dagli anni Quaranta in poi, se si mettessero in fila tutti gli articoli dello scrittore siciliano, si potrebbero ripercorrere le tappe degli avvenimenti della Prima Repubblica.
Dal Corriere della Sera alla Stampa, dai quotidiani siciliani L’Ora e il Giornale di Sicilia che lo assunse come praticante il 24 febbraio 1972, dalle riviste letterarie come Nuovi Argomenti a quelle di attualità come l’Espresso, solo per citare alcune testate, Sciascia scrive su tutto. Sui fasti e, soprattutto, sui nefasti della vita pubblica italiana. Sulla mafia, l’antimafia, il terrorismo. Sull’affaire Moro. Sulle sue passioni letterarie. Sulla Chiesa cattolica. Sul potere “che è sempre altrove”. Sulla Sicilia, metafora del mondo intero.
Per capire l’importanza della produzione pubblicistica di Sciascia, per intendere che ruolo abbia avuto come coscienza critica della società, di quella italiana e di quella siciliana in particolare, basta ricordare l’apice delle polemiche scatenate dall’articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 10 gennaio 1987. Già il titolo: “I professionisti dell’antimafia”, non scelto da Sciascia ma destinato a perpetuarsi – a proposito, ma più spesso a sproposito – aveva provocato un terremoto. L’autore civile per eccellenza, il polemista principe, il primo scrittore, per di più siciliano, ad avere parlato di mafia chiamandola col suo nome in romanzi come “Il giorno della civetta” o “A ciascuno il suo”, finisce sotto processo come un quaquaraquà qualunque. Giornali, politici, qualche magistrato, quella società civile che si ritiene in trincea nella lotta contro la mafia, tutti lo attaccano. E quei pochi che lo difendono lasciano trapelare una punta di imbarazzo, magari sull’eccesso di garantismo.
Lui sceglie i microfoni della Rai per replicare secco a un pubblico più vasto: “In nome dell’antimafia si esercita una specie di terrorismo, perché chi dissente da certi metodi, è subito accusato di essere un mafioso, o almeno un simpatizzante”.
Prevede con largo anticipo “l’antimafia come strumento di potere. Il che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando”. E persevera nell’affermare la sua personale eresia: “Si può scrivere per null’altro che per amore di verità”. Puntualizzando: “Ci sono i fatti. E naturalmente c’è la possibilità di interpretarli, di sfaccettarli come si vuole, dissolverli anche, pirandellianamente…Però, un fatto è un fatto”.
Da allora “la nera scrittura sulla nera pagina della realtà”, il pessimismo della ragione, diventa sempre più sfiducia nel giornalismo in “un paese senza verità” come l’Italia. Un paese senza verità – dalla vicenda della morte del bandito Giuliano, al caso Tortora, al sequestro Moro – a contraddire il suo credo “nell’ intelligere, che è capire, semplificare, rendere chiaro”.
“La lettura dei giornali mi dà neri pensieri” – scrive Sciascia. “I giornali mi si parano davanti come un sipario. Più esattamente come un velario, poiché qualcosa di quel che si muove dietro, della scena che si prepara, la lasciano intravedere. Solo che ci vuole un occhio abituato, un occhio allenato… Di un’esperienza che non tutti hanno”. Un’esperienza che lui aveva. Scrittore in redazione.
Il direttore che gli firmò il contratto per il Giornale di Sicilia nel 1972, Roberto Ciuni, ricorda quegli anni in cui erano diventati giornalisti professionisti Alberto Moravia, fatto praticante dal Corriere della Sera e Michele Prisco per Il Mattino. Praticanti che non dovevano inseguire notizie o impaginare. Piuttosto dovevano esercitare il loro mestiere, frequentando le redazioni a modo loro. Leonardo Sciascia andava al Giornale di Sicilia due o tre volte la settimana.
 “Portava già pronto l’articolo in cartelline dattiloscritte pulitissime, senza ripensamenti, si fermava un poco e vedeva i colleghi che sgobbavano come si sgobba solo nei piccoli quotidiani” – rammenta Ciuni. “Ma un giorno mi disse che non gli sembrava giusto guadagnare quanto quei trafelatissimi praticanti lavorando un decimo. Non riuscii a convincerlo che i primi ad essere contenti di averlo al giornale erano proprio loro”.
“Portava già pronto l’articolo in cartelline dattiloscritte pulitissime, senza ripensamenti, si fermava un poco e vedeva i colleghi che sgobbavano come si sgobba solo nei piccoli quotidiani” – rammenta Ciuni. “Ma un giorno mi disse che non gli sembrava giusto guadagnare quanto quei trafelatissimi praticanti lavorando un decimo. Non riuscii a convincerlo che i primi ad essere contenti di averlo al giornale erano proprio loro”.
Un problema di giustizia, dunque. Ma anche qualcos’altro. Come Ciuni intuì. E come lo stesso Sciascia scrisse anni dopo, in preda ad astratti furori sul ruolo del giornalismo in Italia, sulla sua “impressionante uniformità”, sulla sua omologazione.
“Qualche differenza nel riferire i fatti si può cogliere – avverte Sciascia –. Ma raramente nel giudizio sui fatti. Una indefinita paura sembra attanagliare i giornali. La paura di avere una linea, di assumere i fatti in un giudizio preciso. E’ come la paura di fare il giuoco di qualcuno o di qualcosa, di mettere in discussione quel che è pericoloso discutere, in pericolo quel po’ di sicurezza cui ci si vuole aggrappare. E in realtà il maggior pericolo sta appunto in questo: nell’aver paura di un pericolo.”
Un giudizio severo che trova il culmine nella descrizione del Grande Giornalista “rampante e schiumante come un purosangue capitato in una stalla di brocchi”, nel romanzo testamento di Sciascia: “Il cavaliere e la morte”.
Un personaggio chiave, “dai suoi articoli, cui settimanalmente i moralisti di nessuna morale si abbeveravano, gli era venuta fama di duro, di implacabile; fama che molto serviva ad alzarne il prezzo, per chi si trovava nella necessità di comprare disattenzioni e silenzi”. Alzare il prezzo, appunto. A futura memoria. (giornalistitalia.it)




















 CONVENZIONI
CONVENZIONI