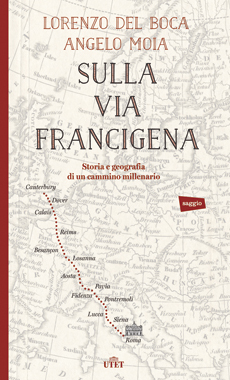TORINO – «Benvenuto in un giornale perbene». Era una fine gennaio del 1995, e l’Avvocato mi accoglieva così nel suo ufficio alla Fiat di corso Marconi. Il Lingotto sarebbe “rinato” più tardi, a rinverdire i fasti di Torino. “La Stampa”, invece, era rimasta la stessa da più di un secolo. Non solo il gioiello di famiglia degli Agnelli, ma un patrimonio prezioso della città e del Paese. Un grande quotidiano costruito su un equilibrio magicamente “glocal”. Radicato nella storia, nella cultura e nell’economia del suo territorio, ma sempre proiettato sui fatti, le tendenze e i cambiamenti del mondo.
Io ci arrivai chiamato da Ezio Mauro che allora la dirigeva, e che di lì a poco si sarebbe trasferito a “Repubblica” (dove due anni dopo sarei rientrato anch’io, per poi passarcene altri 23). Un andare e un tornare che si è ripetuto spesso: da Mario Calabresi a Maurizio Molinari, che ora mi passa il testimone. A conferma di quanto siano intrecciate le vicende di queste due testate, diverse ma unite da una trama identitaria comune, fatta di laicità e modernità, di azionismo e di civismo, di senso dello Stato e di fedeltà ai principi delle liberal-democrazie dell’Occidente.
Oggi sono di nuovo qui, proprio nel giorno della Festa di Liberazione dal fascismo, che di quell’identità condivisa è elemento costitutivo. Torno richiamato da John Elkann, che ringrazio per la stima e la fiducia. E torno con lo stesso orgoglio di allora. Perché in questo, grazie ai direttori che mi hanno preceduto e nonostante le novità che l’hanno caratterizzata, “La Stampa” è quella di sempre: un giornale perbene. Ma torno anche con la consapevolezza di quanto sia buia l’ora che viviamo. I camion militari con le bare per le strade deserte di Bergamo e le fosse comuni scavate nella nuda terra di Hart Island.
La generazione dei nonni, sopravvissuti alla guerra, volata via senza l’ultima carezza e la generazione dei 50enni, cresciuti nella pace, in fila per il pane. Sono immagini e traumi che non si cancellano. Thomas Friedman sul New York Times scrive che la nostra era va ormai divisa “tra un A.C. e un D.C.”, un “Avanti” e un “Dopo”, dove “C” non è Cristo ma è Coronavirus. Contiamo i morti, ma anche i giorni che ci separano dal ritorno a un’esistenza quasi normale. Chiediamo al governo di indicarci una chiara exit-strategy dalla chiusura totale che asfissia 6 milioni di famiglie, brucia 8 punti di Pil e costa 160 miliardi di fatturato industriale. Domani il premier Conte illustrerà la sua road map. Gli altri lo hanno già fatto. Non dirò la solita Germania, dotata di ambulatori sul territorio, 30 mila terapie intensive, 2 milioni di tamponi, mascherine nei luoghi di lavoro. Dico Spagna e Portogallo, colpiti dal Covid in condizioni non migliori delle nostre e tuttavia capaci di venirne fuori prima.
Perché noi non ci riusciamo? Perché restiamo impastoiati negli ingranaggi della macchina Stato-Regioni, Protezione Civile-Comitato Scientifico, Commissione Pisano-Comitato Colao? Perché la ripartenza si perde nel labirinto di 45 fantasmatiche “task force” e 600 presunti esperti? Perché cadono sul campo 200 medici e infermieri e sulla strage nelle Rsa indagano decine di procure? Perché oscilliamo tra Grande Lazzaretto e Colonia Penale?  Questo si chiedono i cittadini, che hanno dimostrato una maturità straordinaria. Ma la pazienza può finire. Dodici milioni di lavoratori aspettano casse integrazioni e bonus ingolfati dalle procedure amministrative, faticano a mangiare e magari si affidano al Welfare delle mafie. Tre milioni di imprese rischiano di essere escluse dalla filiera delle forniture globali e per avere 15 mila euro di prestito “automatico” in banca devono esibire 19 documenti. Si dice: “Ne usciremo migliori”. Non ne sono sicuro. Ci accontenteremmo di poco. Più diritti e meno disuguaglianze. Un sistema di protezione sociale più solido e meno squilibrato. Un fisco più equo e meno evasione. Servizi pubblici con più merito e meno burocrazia.
Questo si chiedono i cittadini, che hanno dimostrato una maturità straordinaria. Ma la pazienza può finire. Dodici milioni di lavoratori aspettano casse integrazioni e bonus ingolfati dalle procedure amministrative, faticano a mangiare e magari si affidano al Welfare delle mafie. Tre milioni di imprese rischiano di essere escluse dalla filiera delle forniture globali e per avere 15 mila euro di prestito “automatico” in banca devono esibire 19 documenti. Si dice: “Ne usciremo migliori”. Non ne sono sicuro. Ci accontenteremmo di poco. Più diritti e meno disuguaglianze. Un sistema di protezione sociale più solido e meno squilibrato. Un fisco più equo e meno evasione. Servizi pubblici con più merito e meno burocrazia.
È il vero inciampo della Fase Due (ma anche Tre e Quattro): gli italiani sono pronti a ripartire, lo Stato no. Il caso “Immuni” è un paradigma: vogliamo tracciare i contagiati sul modello Corea/Israele, ma non sforniamo la app domattina, la studiamo per settimane con 2 commissioni e 90 commissari. Il Coronavirus è il pettine della Storia: fa venir fuori tutti i nodi irrisolti del Paese. Il compito del buon giornalismo è descriverli, aiutando il lettore a comprenderli e sollecitando la politica ad affrontarli.
È quello che faremo. Con una certezza: per non scivolare in una Lunga Depressione, quei nodi andranno sciolti con la competenza dell’establishment e la pazienza del confronto, non tagliati con la spada della semplificazione populista. Serviranno altri sacrifici, perché abbiamo un debito al 155% del Pil e i Piani Marshall a fondo perduto sono finiti nel 1950. Serviranno classi dirigenti all’altezza della sfida. Serviranno “strumenti eccezionali per tempi eccezionali”, come dice Mario Draghi.
Garantire reddito e benessere dei popoli è l’unico modo per disarmare gli eserciti nazional-sovranisti e arginare le mire imperiali di Cina e Russia, che approfittano del virus per riorientare l’asse strategico del pianeta. Nonostante i parziali passi avanti compiuti dal Consiglio europeo di giovedì, l’Unione è in ritardo. Ma anche qui, un avviso ai nostalgici delle lirette e ai fanatici delle “democrature”: per l’Italia la sola comunità di destino è in Europa (nonostante l’Olanda di Rutte) e la sola collocazione geopolitica è nell’Alleanza Atlantica (nonostante l’America di Trump). Dobbiamo esserne coscienti, mentre c’è chi per palese imperizia si perde sulle Vie della Seta e chi per riflesso ideologico trasforma in scorie radioattive i 36 miliardi di preziosi aiuti sanitari del Mes.  È vero: il globalismo sregolato, pur avendo affrancato dalla fame i derelitti dell’emisfero Sud, ha “proletarizzato” i ceti medi dell’emisfero Nord. Ha accelerato le migrazioni, generando insicurezza e intolleranza in milioni di occidentali che vedono la stessa pandemia come il frutto avvelenato del melting-pot. Ma la risposta a tutto questo non può essere una deglobalizzazione illogica e antistorica.
È vero: il globalismo sregolato, pur avendo affrancato dalla fame i derelitti dell’emisfero Sud, ha “proletarizzato” i ceti medi dell’emisfero Nord. Ha accelerato le migrazioni, generando insicurezza e intolleranza in milioni di occidentali che vedono la stessa pandemia come il frutto avvelenato del melting-pot. Ma la risposta a tutto questo non può essere una deglobalizzazione illogica e antistorica.
Il dominio della Tecnica sulla Natura e sulla Politica ci ha illuso di essere infallibili e immortali. Il Covid ci ha presentato il conto. Dobbiamo imparare la lezione. Non facendo un passo indietro, verso un Medio Evo pauperista e anticapitalista, ma un salto in avanti. È la scienza, la ricerca, la tecnologia che ci salveranno dal Male, non la famosa e fumosa decrescita felice. Dobbiamo progettare un modo diverso di vivere, consumare e produrre. E qui sta l’altra parte della nostra missione, quella più affascinante. Il buon giornalismo deve saper cogliere tutto il buono e il nuovo che c’è, in Italia e nel mondo. Perché ce n’è tanto, per chiunque abbia curiosità e coraggio di cercare. Dai 7 milioni di volontari che aiutano il prossimo all’azienda di Brescia che, con una valvola stampata in 3D, riconverte maschere da snorkeling in respiratori polmonari. La Storia non finirà neanche stavolta. Si tratta solo di avere occhi per osservarla e testa per decifrarla.
 “La Stampa” è cambiata e cambierà ancora. Con la forza delle sue idee e la dedizione di tutti coloro che, ogni giorno, le danno linfa vitale e professionale: dai giornalisti ai tipografi, dai grafici ai fotografi, dai collaboratori ai dipendenti. Siamo già il primo quotidiano “digital first”, dove tutte le piattaforme (carta, sito e social) sono integrate. Lo saranno sempre di più, in un ciclo continuo di notizie e commenti, reportage e video, newsletter e podcast. La Rete non è il futuro, è il presente. Ma nel flusso impetuoso e indistinto della “mediasfera” l’informazione qualificata è “merce” sempre più pregiata. Noi cercheremo di garantirla ogni giorno, con il contributo formidabile del network dei nostri giornali locali. Non si tratta più di convincere il lettore a cercare il suo quotidiano in edicola. Si tratta di raggiungerlo ovunque e in ogni momento con contenuti di alta qualità e affidabilità, sul suo smartphone, sul suo iPad, sul suo Pc. “Democrazia e giornalismo libero moriranno o progrediranno insieme”, scriveva Joseph Pulitzer nel 1902. Era già vero allora, per noi è ancora più vero oggi.
“La Stampa” è cambiata e cambierà ancora. Con la forza delle sue idee e la dedizione di tutti coloro che, ogni giorno, le danno linfa vitale e professionale: dai giornalisti ai tipografi, dai grafici ai fotografi, dai collaboratori ai dipendenti. Siamo già il primo quotidiano “digital first”, dove tutte le piattaforme (carta, sito e social) sono integrate. Lo saranno sempre di più, in un ciclo continuo di notizie e commenti, reportage e video, newsletter e podcast. La Rete non è il futuro, è il presente. Ma nel flusso impetuoso e indistinto della “mediasfera” l’informazione qualificata è “merce” sempre più pregiata. Noi cercheremo di garantirla ogni giorno, con il contributo formidabile del network dei nostri giornali locali. Non si tratta più di convincere il lettore a cercare il suo quotidiano in edicola. Si tratta di raggiungerlo ovunque e in ogni momento con contenuti di alta qualità e affidabilità, sul suo smartphone, sul suo iPad, sul suo Pc. “Democrazia e giornalismo libero moriranno o progrediranno insieme”, scriveva Joseph Pulitzer nel 1902. Era già vero allora, per noi è ancora più vero oggi.
Massimo Giannini













 CONVENZIONI
CONVENZIONI