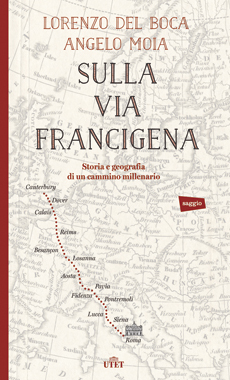ROMA – In Turchia basta un solo dipinto, postato sui social, per finire in carcere. E per rimanerci 2 anni, 9 mesi e 22 giorni. Non è una cosa da poco. Soprattutto se la protagonista di questa storia, di anni, non ne ha ancora compiuti trenta. Zehra Doğan non è solo un’artista. È una giornalista, una fotografa, una delle collaboratrici di Jinha, un’agenzia di stampa curda che prova a raccontare, con mille difficoltà, cosa sta succedendo nel Paese di Erdogan. L’intero staff dell’agenzia è composto da sole giornaliste che si battono anche per la difesa dei diritti delle donne, soprattutto appartenenti a quella minoranza etnica. Il 21 luglio 2016, il giorno in cui è stata arrestata, Doğan era in un bar di Nusaybin, cittadina turca al confine con la Siria, dove viveva e lavorava.
L’accusa è quella di essere un’affiliata di un’organizzazione illegale anti-governativa. È una sorta di cospiratrice. Durante la prima udienza, diversi testimoni hanno confermato la sua “colpa” senza che nessuno, però, sapesse indicare quale fosse il suo vero nome e basandosi, semplicemente, sul suo aspetto fisico: “una piccola donna con un anello al naso”. Troppo poco anche per il giudice che, in prima istanza, la assolve. Nessuna condanna e una scarcerazione, il 9 dicembre. Dopo sei mesi passati in prigione. Ma il processo non è finito. Zehra Doğan è una che racconta storie scomode. Ed è capace di farlo non solo con le parole. Usa il pennello, la matita, la voce. Disegna, parla, illustra, scrive.
Il 2 marzo del 2017 arriva quella che, in fin dei conti, è un vero tentativo di censura. Assolta per non aver fatto parte di una organizzazione illegale, certo, ma condannata per la pubblicazione di un dipinto sui suoi social network. Uno. Questo (che pubblichiamo, ndr).
L’immagine di una città distrutta
L’opera di Doğan racconta la distruzione di Nusaybin da parte delle forze di sicurezza nazionali. Con le bandiere turche appese sulle case distrutte, ben visibili, in uno scenario apocalittico. Una denuncia di quello che stava succedendo lontano da Istanbul o da Ankara e che stava colpendo, nel silenzio generale, migliaia di civili. E di innocenti. Una rappresentazione della realtà che, per le autorità locali, sarebbe la prova della diffusione consapevole di una “propaganda terroristica” e della vicinanza al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK).
Durante il processo, la difesa di Doğan è stata quella di aver realizzato quella, e altre opere, all’interno della sua attività giornalistica. Pur cronaca. Difesa che ha ribadito in un tweet, ora scomparso: “Ho ricevuto una condanna di due anni e 10 mesi solo perché ho dipinto bandiere turche su edifici distrutti. Ma è stato il governo a causare tutto ciò. Io l’ho solo dipinto”.
Giornalista e artista, anche in carcere
Già nel 2015 il nome di Doğan era diventato scomodo e mal tollerato dalle autorità. In quel periodo aveva scritto una serie di articoli sulle donne Yazide che erano riuscite a fuggire dalla prigionia imposta dall’Isis e dalle terribili vessazioni subite. Un lavoro di testimonianza che le era valso il premio Metin Göktepe Journalism Award, il riconoscimento conferito per ricordare Metin Göktepe, il giornalista torturato e assassinato, nel 1996, dalla polizia turca.
Non è difficile immaginare, dunque, quanto le sbarre della prigione femminile di Mardin non siano state in grado di fermare la volontà di Doğan di raccontare le ingiustizie subite dal suo popolo e dai suoi colleghi. Insieme ad altre donne, ad esempio, ha creato una pubblicazione illustrata, Özgür Gündem Zindan, ispirata a un giornale filo-curdo, con sede a Istanbul, poco tollerato (e per questo spesso chiuso) dal governo.
Il sostegno di Banksy e di altri artisti
In questi giorni la storia di Zehra Doğan è stata rilanciata da molte testate. Il merito è di un altro artista, Banksy, forse il più noto, e misterioso, street artist del mondo. L’ultima sua opera è comparsa tra Houston Street e Bowery, a New York. Un murale, lungo più di 21 metri, realizzato insieme all’artista Borf, e dedicato proprio alla giornalista turca.
L’artista inglese ha voluto esprimere la sua vicinanza anche attraverso l’hashtag #FREEzehradogan e un commento, molto sentito, al New York Times. L’opera di Banksy ripropone una parete di una prigione composta da molte sbarre che identificano le celle detentive. Una accanto all’altra. Linee che rappresentano però anche il numero di giorni di libertà che sono stati sottratti a Zehra Dogan. Da una di queste celle spunta il suo viso e le sue mani che stringono le sbarre. Una, però, è anche una matita. La sera di giovedì, sul murale, è stato proiettato il dipinto “incriminato”.
Banksy non è il primo artista che si occupa di denunciare l’ingiustizia subita dalla giornalista. Lo scorso novembre, ad esempio, fu l’artista cinese Ai Weiwei a scriverle. Il sito Voice Project ha creato una petizione, a cui chiunque può aderire, diretta al primo ministro turco, per far sì che venga liberata. Ad oggi, però, la situazione non è cambiata. Zehra Dogan dovrà passare ancora 18 mesi in carcere. Per un dipinto. Uno. (agi)











 CONVENZIONI
CONVENZIONI