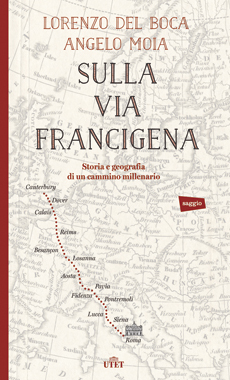ROMA – II secondo dei due grandi miti che pesano da sempre sulla professione giornalistica è che essa rappresenti una qualche forma di potere. II primo mito l’abbiamo visto: il giornalismo non come mediazione tra la fonte e i fruitori del messaggio; non come accertamento – nella realtà che ci circonda col suo incessante corso di accadimenti – dell’evento meritevole di diventare materia di fruizione, cioè di diventare notizia; non come capacità di raccontare le cose, ossia i fatti, le vicende, con un linguaggio comprensibile ai lettori; non come soddisfacimento dei bisogni informativi del cittadino-lettore, dei suoi interessi, delle sue curiosità; non come scienza del contingente e della quotidianità, non come supporto di storiografia ed esso stesso, in certo modo, storiografia; bensì il giornalismo come qualcosa che attiene alla letteratura, come un’attività letteraria, come esercizio di bella scrittura, come culto della prosa elegante (o creduta tale), come ricerca formale al di là dei contenuti, come compiacimento estetizzante e narcisistico.
È il mito legato alla fatidica domanda “giornalisti si nasce o si diventa?”, alla quale chi la pone sa già come rispondere: che il giornalismo non è un mestiere come tutti gli altri, che non si esaurisce nei suoi contenuti tecnici, culturali e, se vogliamo, ideali, ma si risolve sempre in “qualcos’altro”, una dote innata, un privilegio di natura; una capacità misteriosa (fiuto, intuito, sensibilità?), che non necessariamente presuppone studio, conoscenze culturali e linguistiche, capacità di analisi critica, gusto della ricerca anche se paziente e faticosa, e infine il possesso dei necessari strumenti semantici insieme all’umiltà di servirsene nell’interesse di quel vasto universo di lettori che dal giornalismo aspettano non verità prefabbricate ma gli elementi per essere più liberi e per migliorare la qualità della propria vita.
Il secondo mito ha anch’esso radici lontane ed è stato reso ufficiale da quando, un secolo e mezzo fa, alla Camera dei Comuni, Edmund Burke, statista e scrittore politico, defini il giornalismo come il “quarto potere” accanto al legislativo, all’esecutivo e al giudiziario; molto probabilmente il deputato Burke intendeva dire che, in un sistema democratico, la stampa esercita un potere di controllo sugli altri tre poteri, nella misura in cui si fa portavoce dell’opinione pubblica; ma oggi la funzione appare spesso ribaltata, e il giornalismo, più che rendersi interprete dei cittadini, si fa invece strumento, sui cittadini, di altri poteri, politici o economici; ed è questa politicizzazione della stampa italiana fino dalle sue origini ottocentesche che ha dato alimento al protagonismo del giornalista e alla sua convinzione che la professione giornalistica sia un’attività socialmente aristocratica, che nasce e si conclude in ambienti altamente qualificati.
Sergio Lepri
“Scrivere bene e farsi capire – Manuale di linguaggio per chi lavora nel
campo della comunicazione” (1988, Gutenberg 2000)










 CONVENZIONI
CONVENZIONI