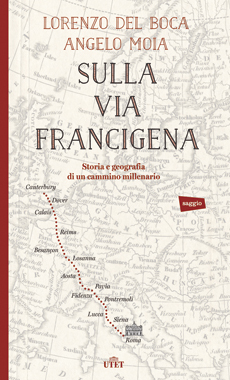ROMA – Abbiamo letto che in questo nefasto 2020 si registra un numero di morti tra i giornalisti inviati nelle zone di guerra (ma anche in altre aree “pericolose” sotto il profilo politico, economico e sociale) sensibilmente inferiore rispetto alla media degli ultimi anni, al momento “solo” 32 (erano 49 nel 2019, 80 nel 2018!). È un dato significativo e favorevole che, però, porta ad alcune riflessioni. La pandemia in atto ha modificato i piani di intervento di testate giornalistiche, televisive e radiofoniche, con un ridotto ricorso agli inviati a causa delle limitazioni imposte. Naturalmente, il rischio è diminuito, così come sono diminuite – in forza di un semplice rapporto sulle potenzialità – anche altre forme di violenza come le prese in ostaggio, le “sparizioni”, le detenzioni in carcere.
La pandemia ha calamitato l’attenzione dei media, ma in questo momento nel mondo ci sono guerre, civili, separatiste, religiose, nell’America Centrale e del Sud, in Asia, nel Medio Oriente, nel continente africano soprattutto, con conflitti civili che interessano Congo, Burundi, Costa d’Avorio, Algeria, Liberia, Somalia, Uganda, Nigeria e separatisti nel Senegal.
E continua la guerra civile in Afghanistan tra i Talebani e l’Alleanza del Nord, quella che costò la vita – al pari di decine di militari italiani là impegnati nella “missione di pace” e centinaia di stranieri – alla giornalista Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, il 19 novembre 2001, diciannove anni fa, uccisa assieme al collega spagnolo di El Mundo, Julio Fuentes, e a due corrispondenti dell’Agenzia Reuters, l’australiano Harry Burton e l’afghano Azizullah Haidari. Un attentato che, come la quasi totalità delle uccisioni dei giornalisti, rimase impunito e per il quale nessuna organizzazione ne rivendicò la paternità.
Delle guerre in corso, però, ora abbiamo notizie frammentarie o “di ritorno” e il rischio oggettivo, per la mission costituita dal mondo dell’informazione, è quello di perdere di vista focolai che possano avere una rilevanza, diretta o indiretta, sull’intero pianeta, meglio occultabili da chi da questi conflitti ne trae vantaggi. Dietro guerre civili e separatiste, è noto, vi sono interessi di Paesi apparentemente estranei o indifferenti, come avviene per quella nel Nagorno Karabakh tra Armenia ed Azerbaigian, riesplosa di recente.
La salvaguardia dei giornalisti è sacra, ma il diritto ad ottenere informazioni sulla verità dei fatti e su ciò che c’è dentro le loro pieghe non può essere trascurato, anche perché con la riduzione o la soppressione degli inviati si creerebbe un pericoloso precedente che sminuirebbe l’importanza della loro presenza negli organici degli editori e sarebbe un’occasione per riconvertirli in giornalisti da tastiera, a minor costo.
Non si dimentichi che nell’ultimo articolo di Maria Grazia Cutuli, pubblicato dopo la sua morte, vi era cenno della scoperta di un deposito di gas nervino nella base di Osama Bin Laden e che notizie del genere si acquisiscono solo sul campo. Strano destino, quello della Cutuli, siciliana, che prima di andare al Corriere della Sera aveva iniziato a lavorare a “La Sicilia”, il quotidiano sul quale aveva scritto anche Beppe Alfano, ucciso dalla mafia.
C’è qualcosa che accomuna le guerre, quelle di mafia e quelle vere. È la morte, e lei la morte la trovò in quella realtà afghana che così descrisse: «Città di spie, Kabul, messe alle costole di ogni straniero. Capitale di macerie, di mendicanti che stazionano a ogni incrocio, di bambini laceri e affamati». Anche in Sicilia era, e per molti verso lo è ancora, così.
Ma oggi si muore anche di Covid e i giornalisti, inviati o meno nei luoghi di questa “guerra”, stanno pagando un prezzo molto alto: solo in Italia sono al momento più di venti ad essere stati contagiati in maniera letale dal virus. Per narrare i fatti, come facevano Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, Giancarlo Siani, Mario Francese e tantissimi altri, ma anche per scoprire cosa può esserci dentro le verità che i giornalisti non cesseranno mai di cercare. (giornalistitalia.it)












 CONVENZIONI
CONVENZIONI