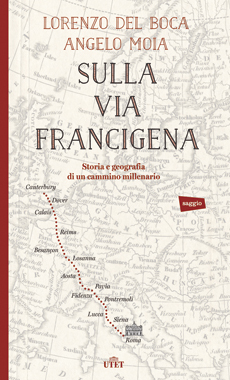ROMA – Il sostituto procuratore generale Antonio Sensale, già pubblico ministero del processo cosiddetto “Mafia Capitale”, ha presieduto più volte la Commissione d’esame di Stato per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti. In questa intervista affronta, quindi, non solo i temi della giustizia, ma quelli legati alla professione giornalistica, anche in virtù dell’osservatorio privilegiato che ha avuto l’onore di presiedere. Narrando episodi, a volte anche grotteschi, esprime giudizi su alcuni modi di titolare le inchieste e sulla preparazione complessiva dei giornalisti.
– Lei è andato in pensione da poco tempo, da Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. Vogliamo ricordare ai lettori qual è stato il suo ultimo processo?
«Neppure ricordo quale sia stato l’ultimo processo trattato, anche perché sono andato in pensione per raggiunti limiti di età durante il lockdown dovuto alla pandemia, mentre l’attività era rallentata. Processi di rilievo, naturalmente, ne ho trattati diversi anche nei miei ultimi anni di servizio a Roma, alla Procura Generale, come lei ricorda, cioè sostenendo la pubblica accusa nel secondo grado di giudizio davanti alla Corte d’Appello.
È chiaro che quelli che hanno richiesto il maggiore impegno sono stati quello per bancarotta fraudolenta delle società collegate all’ex impero di Vittorio Cecchi Gori, e quelli in tema di criminalità organizzata: uno contro la “locale” di ‘ndrangheta Gallace insediatasi a Nettuno, se ben ricordo, ed ovviamente il processo contro Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e tanti altri, che grande eco ha avuto sugli organi di informazione».
– I giornali, non tutti per la verità, quando riferirono sulle indagini e poi sul processo hanno usato la dizione “Mafia capitale’’. Secondo lei è esatta? Si può parlare di infiltrazioni della mafia, o solo criminali tout court, nel tessuto economico di Roma?
«Invero, ho sempre detestato l’abitudine, creata dagli organi investigativi ed entusiasticamente abbracciata dalla stampa per ragioni di brevità, di appioppare denominazioni sintetiche e di fantasia, quasi mai appropriate, alle indagini ed ai processi più complessi, a partire da “Mani Pulite” e da “Operazione Maglio”, che seguii come Gip a Napoli negli anni ’90: lo stesso vale per “Mafia Capitale”, anche a prescindere dall’esito finale in Cassazione, dove la natura mafiosa delle attività in questione – dopo essere stata affermata dalla Corte d’Appello in linea con la Procura Generale, anche da me rappresentata – è stata inopinatamente esclusa, ribaltando numerose pronunce della stessa Cassazione nelle prime fasi del medesimo processo.  Come da noi affermato nella requisitoria in aula di Appello, non poteva ravvisarsi una pervasività della malavita organizzata come di quelle tradizionali, in grado di controllare tutte o quasi le attività economiche di una megalopoli come Roma (sarebbe stato impossibile), ma piuttosto una pericolosa liaison tra gruppetti dalla storia schiettamente criminale ed il sistema monopolistico degli appalti creatosi nelle Amministrazioni capitoline grazie ad assessori, consiglieri e funzionari corruttibili e spesso legati anch’essi ad un passato oscuro».
Come da noi affermato nella requisitoria in aula di Appello, non poteva ravvisarsi una pervasività della malavita organizzata come di quelle tradizionali, in grado di controllare tutte o quasi le attività economiche di una megalopoli come Roma (sarebbe stato impossibile), ma piuttosto una pericolosa liaison tra gruppetti dalla storia schiettamente criminale ed il sistema monopolistico degli appalti creatosi nelle Amministrazioni capitoline grazie ad assessori, consiglieri e funzionari corruttibili e spesso legati anch’essi ad un passato oscuro».
– Facciamo un salto all’indietro, anzi cominciamo dall’inizio. Come e perché scelse di entrare nella magistratura? Aveva qualche esempio in famiglia?
«Ha colto nel segno! Decisivi per la mia decisione di vestire la toga furono due miei zii – uno dei quali mio omonimo, il fratello di mio padre – che stavano vivendo entrambi un cursus honorum molto brillante ed assolutamente meritato. La mia prima sede, dopo il tirocinio, fu il Tribunale di Como, dove arrivai come giudice molto giovane, a 27 anni (allora si iniziava abbastanza presto), e mi resi rapidamente conto che tutto il mondo ideale che mi ero formato sull’attività della giustizia e sulla figura dei suoi interpreti era piuttosto esagerato, in quanto incontrai persone e vicende che non incarnavano esattamente quello che io ritenevo dovesse essere il magistrato perfetto. Ma imparai presto ad orientarmi, affiancandomi a colleghi ed avvocati di grande levatura, che mi fecero da guida.  All’epoca (1977/1980) i Tribunali di confine come il mio erano sepolti dai processetti per direttissima per esportazione illecita di valuta, reato poi rapidamente soppresso dal legislatore; inoltre iniziavano le infiltrazioni in Lombardia di gruppi malavitosi provenienti dal sud Italia, dediti a rapine e sequestri di persona, per cui il lavoro anche duro non mancava. Però il processo di quel periodo che ricordo con maggiore affetto aveva ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, che noi ritenemmo esteso anche ad un campeggio sul lago di Como fornito di basamenti fissi: e la Cassazione ci diede ragione!».
All’epoca (1977/1980) i Tribunali di confine come il mio erano sepolti dai processetti per direttissima per esportazione illecita di valuta, reato poi rapidamente soppresso dal legislatore; inoltre iniziavano le infiltrazioni in Lombardia di gruppi malavitosi provenienti dal sud Italia, dediti a rapine e sequestri di persona, per cui il lavoro anche duro non mancava. Però il processo di quel periodo che ricordo con maggiore affetto aveva ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, che noi ritenemmo esteso anche ad un campeggio sul lago di Como fornito di basamenti fissi: e la Cassazione ci diede ragione!».
– Lei notoriamente, e non solo perché è napoletano, è un uomo di spirito, che tende a sdrammatizzare con una battuta certe situazioni. Può ricordare ai lettori un episodio in cui durante una requisitoria chiese la pena di morte e nessuno, neanche il giudice, mostrò di avere inteso? O forse ricordo male l’episodio?
«Lei ricorda benissimo, si tratta di un episodio avvenuto davanti alla Corte di Appello di Napoli, intorno al 2010. Per dimostrare a due giovani avvocati che il disinteresse con cui i giudici di quella Corte seguivano i processi e le requisitorie pronunciate davanti a loro era lo stesso anche per il magistrato della Procura Generale (dove io lavoravo già all’epoca), al termine di una requisitoria chiesi a voce piena la condanna a morte dell’imputato “mediante impiccagione”: le mie parole nel silenzio dell’aula provocarono le risate clamorose dei due giovani avvocati e di altri loro colleghi, ma non furono neppure percepite dai giudici della Corte, che continuarono distrattamente la loro attività di udienza».
– Come magistrato, e come prevede la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, ha presieduto più volte la Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione giornalistica. Che idea si è fatto, sinceramente, della preparazione dei candidati, e in generale del livello culturale dei giornalisti?
 «L’esperienza della presidenza delle commissioni nazionali per l’abilitazione dei giornalisti, ripetutasi nel 2015 e nel 2017, è stata tra la più gradevoli della mia vita di lavoro, anche perché l’ho condivisa con magistrati e giornalisti di notevole spessore. Come tutti avemmo modo di constatare, il livello di preparazione generale dei candidati – al di là di tante splendide eccezioni – lasciava mediamente a desiderare: ma si tratta di un problema generazionale, comune alle giovani leve della magistratura e della avvocatura, per cui non c’è da meravigliarsi».
«L’esperienza della presidenza delle commissioni nazionali per l’abilitazione dei giornalisti, ripetutasi nel 2015 e nel 2017, è stata tra la più gradevoli della mia vita di lavoro, anche perché l’ho condivisa con magistrati e giornalisti di notevole spessore. Come tutti avemmo modo di constatare, il livello di preparazione generale dei candidati – al di là di tante splendide eccezioni – lasciava mediamente a desiderare: ma si tratta di un problema generazionale, comune alle giovani leve della magistratura e della avvocatura, per cui non c’è da meravigliarsi».
– Ricorda qualche svarione clamoroso durante le interrogazioni ?
«Certo, l’episodio della candidata, probabilmente bravissima nel settore della moda, che ignorava radicalmente una vicenda drammatica ed emblematica della storia italiana quale la strage delle Fosse Ardeatine, è entrata nella memoria collettiva di tutti noi commissari, tanto da essere già stata pubblicata nel suo libro Il curioso giornalista. La povera ragazza, quando cercai di aiutarla collegando la strage all’attentato di via Rasella a Roma, cadde dalle nuvole quasi indispettita affermando che, essendo di Bergamo, non era tenuta a conoscere il nome delle strade di Roma!
Ma c’è un altro episodio emblematico. Un pomeriggio, trattando l’argomento dei senatori a vita, e riusciti faticosamente ad apprendere da un candidato che tra questi rientravano di diritto gli ex Presidenti della Repubblica, ebbi l’ardire di chiedergli quali fossero i Presidenti Emeriti ancora in vita (all’epoca erano Ciampi e Napolitano); dopo dieci minuti di stranguglioni, diventato paonazzo, il candidato finalmente si illuminò e rispose: Bettino Craxi! Craxi all’epoca era defunto da 15 anni e non salì mai al Quirinale».
– Ricordo che in certi momenti di tensione dell’esame orale, Lei veniva quasi in soccorso perlomeno per introdurre una nota di alleggerimento. Un esempio tra i tanti: a proposito delle carte deontologiche ( che hanno nomi delle città dove sono state varate: di Treviso, di Perugia, di Firenze, di Roma) lei chiedeva al candidato: Mi parli della Carta di Campobasso. Il candidato non faceva in tempo a mostrarsi stordito che Lei interveniva sorridendo per chiarire che era uno scherzo.
«Lei ha un’ottima memoria! Tuttavia, le mie domande apparentemente scherzose sulle Carte deontologiche di Campobasso o di Catanzaro erano un vero e proprio trabocchetto per il candidato, perché se non sapeva che quelle Carte erano una pura invenzione e andava in confusione, dimostrava di non conoscere granché l’argomento e di non sapere quali fossero le vere carte deontologiche. Comunque, è vero che a volte, per aiutare i candidati a vincere la comprensibile tensione, sia io sia gli altri commissari cercavamo una battuta sorridente. Come può testimoniare il segretario della Commissione, l’impareggiabile Saverio Cicala».
– Quali sono le qualità essenziali, direi imprescindibili, che fanno un buon giudice?
«Oltre alle doti comuni ad ogni magistrato, ovvero una buona preparazione giuridica e processuale, sicuramente rientra tra le qualità essenziali di un buon giudice la capacità di cogliere con lucidità il punto focale di ogni questione, civile o penale che sia; ma in più il giudicante deve possedere una grande onestà intellettuale, che lo aiuti ad essere indipendente da ogni legame anche solo ideologico in senso ampio, ed anche un grande equilibrio psicologico, che può nascere solo da una profonda serenità personale e da una totale umiltà: quanti ne ho conosciuti di giudici ma anche di pm ammalati della sindrome: “ora vi faccio vedere io come si fa”! Sono i peggiori».
 – Sono le stesse qualità che deve avere il pubblico ministero, o sono diversificate?
– Sono le stesse qualità che deve avere il pubblico ministero, o sono diversificate?
«Oltre a quelle dette pocanzi e comuni ai giudicanti, il magistrato del pm deve possedere un forte capacità di intuizione, ma anche la calma per saper soppesare in maniera autonoma le ipotesi investigative che inevitabilmente gli vengono sottoposte dagli organi della polizia giudiziaria: non sempre la realtà è come appare all’inizio; inoltre il pm, come e più del giudicante, deve avere quelli che il mio bravissimo ex collega Carofiglio definisce “i ragionevoli dubbi”; né va dimenticato che il magistrato nulla può se non è circondato da collaboratori preparati e molto svegli durante la fase delle indagini. In udienza, poi, al magistrato del pm si richiedono prontezza, conoscenza degli atti e a volte anche coraggio per fronteggiare i sempre possibili tentativi di sviamento da parte di qualche avvocato difensore».
– Lei come giudica l’ipotesi di separare le funzioni, giudicante e requirente? O è bene che il magistrato faccia l’esperienza sui due diversi fronti, anche per capire meglio le esigenze e le logiche dell’una e dell’altra funzione?
«Sono sempre stato e resto assolutamente contrario alla ormai realizzata separazione tra funzione giudicante e funzione requirente, purtroppo iniziata già nel 2006 con il Guardasigilli Mastella. Come anche gli avvocati più esperti ed avveduti riconoscono, per essere un bravo pm bisogna avere una profonda cultura della giurisdizione, proprio come il giudice: ovvero, bisogna capire e riconoscere se le indagini in corso possono portare a risultati di verità o se il materiale probatorio raccolto è insufficiente, dinanzi al giudice, per potere serenamente richiedere una condanna. Il rischio più grave, già da qualche anno senza freni, è che il pm sia solo il frontman o il portavoce della polizia giudiziaria e che, separando, si ritenga normale sottoporre le Procure all’indirizzo necessariamente politico del governo di turno. Ricordo che il giudice istruttore penale del vecchio codice doveva essere, e solitamente era, un buon giudice del materiale di indagine da lui stesso raccolto durante la cosiddetta istruzione formale. È stata la funzione più bella che abbia svolto!».
– Ora che non ha vincoli di riservatezza o di …prudenza, si può sbilanciare con qualche risposta. Chi è stato il miglior ministro della Giustizia secondo Lei?
«Durante la mia ultraquarantennale attività ho visto passare un numero tanto elevato di ministri della Giustizia che neppure li ricordo tutti. Posso dire che apprezzai il breve e fugace tentativo fatto nel 1999 dal ministro Diliberto di riformare radicalmente il mondo penitenziario. Ma, ripeto, non sono in grado di stilare una graduatoria di merito, anche perché so bene che la politica legislativa dipende solo in parte dal ministro in carica».
– E il peggiore?
«Ribadisco che non saprei dire quali siano stati i peggiori ministri passati da via Arenula. Ricordo, però, bene che il Guardasigilli Castelli – che era un ingegnere, ma non credo fosse questo il problema – bloccò per anni i concorsi per l’accesso alla magistratura, costringendo tanti giovani laureati a mordere il freno, per il conclamato progetto di quella parte politica di includere nell’ordine giudiziario migliaia e migliaia di magistrati onorari temporanei, vale a dire laureati in giurisprudenza ma non vincitori di alcun concorso, in tal modo “annacquando” la qualità media della magistratura italiana e riducendone inevitabilmente l’autonomia e l’indipendenza».
– Di Marta Cartabia che idea si è fatto?
«Non saprei che dire dell’attuale ministro Cartabia, che mi sembra si stia limitando a portare a termine il compitino già predisposto da altri nel corso degli ultimi decenni. Né mi sembra, pur essendo un avvocato, che abbia una grande esperienza sul campo, ovvero della vita quotidiana dei Tribunali e dei reali problemi di tutti gli operatori della giustizia».
– Cosa risponde a chi dice che la magistratura è una casta intoccabile?
«Ritengo che quella della casta sia una favola assolutamente ingenerosa e non rispondente alla realtà degli ultimi decenni. Forse il concetto poteva attagliarsi alla magistratura di oltre cinquanta anni fa, che vedeva perpetuarsi nell’ordine giudiziario sempre i rampolli delle stesse famiglie di magistrati, avvocati o notai: ma allora la magistratura era blandita accuratamente dagli esponenti della politica, ben consapevoli che nessun controllo “quella” magistratura avrebbe svolto sulla loro attività pubbliche o private.
Ora che l’accesso alla professione si è da tempo ampliato ad esponenti di classi sociali non tradizionali, direi che la casta è quella dei politici che non accettano di essere uguali ad ogni altra categoria di cittadini; possono esserci consorterie di magistrati più noti e potenti di altri (il caso Palamara docet, ma non è il primo), ma il difetto mi sembra quello opposto: ovvero il desiderio individualistico di molti di porsi in luce e primeggiare ritenendosi migliori degli altri».
– Condivide la organizzazione dei magistrati in correnti, spesso in correnti che fanno politica quasi militante?
«Quanto alle correnti, solo chi è in mala fede e vuole pilotare dall’alto magistratura e Csm può considerarle alla stregua di associazioni a delinquere. In realtà, fino ad un recente passato le correnti erano libere associazioni di magistrati spinti da una visione comune dei problemi e della funzione della giustizia: non v’è dubbio che proprio il fervido confronto tra le correnti ed loro esponenti di spicco ha consentito di superare quella che una volta era una giustizia “di classe”, forte con i deboli e debole con i forti.  C’è stato poi sicuramente un appiattimento delle correnti tra di loro quando la magistratura nel suo complesso ha dovuto fare fronte comune contro il potere politico che, insofferente ad ogni possibile controllo, tentava di screditarla o di limitarne l’indipendenza. È iniziata allora, a mio avviso, lo sbiadirsi delle differenze ideali tra le correnti, che le ha trasformate poco a poco in centri di potere, divenuti poi necessari per progredire in carriera. Ma, per concludere, le recentissime riforme sul Csm mi sembrano soltanto punitive per i magistrati e destinate a non incidere sulle deformazioni del sistema».
C’è stato poi sicuramente un appiattimento delle correnti tra di loro quando la magistratura nel suo complesso ha dovuto fare fronte comune contro il potere politico che, insofferente ad ogni possibile controllo, tentava di screditarla o di limitarne l’indipendenza. È iniziata allora, a mio avviso, lo sbiadirsi delle differenze ideali tra le correnti, che le ha trasformate poco a poco in centri di potere, divenuti poi necessari per progredire in carriera. Ma, per concludere, le recentissime riforme sul Csm mi sembrano soltanto punitive per i magistrati e destinate a non incidere sulle deformazioni del sistema».
– È sempre tifoso del Napoli? Quest’anno sarà la volta buona che riconquista lo scudetto?
«La domanda è provocatoria: come si fa a non essere più tifoso del Napoli? La mia squadra ha mancato quest’anno un’occasione storica per vincere il campionato e non avrà per chissà quanti anni un’occasione simile!».
– Di solito i magistrati che dismettono la toga si mettono a scrivere libri. Lei come impiega il tempo? Ha nel cassetto qualche progetto di scrittura?
«Vorrei tanto essere andato davvero in pensione, ma ho un figlio ragazzino ed una giovane moglie che necessitano di essere accompagnati in una vita piena di impegni, sia di studio che di socialità. Ora, superata verosimilmente la pandemia, ci stiamo rimettendo a viaggiare e pertanto non ho molto tempo per scrivere dei libri: oltretutto, se allude a libri di ricordi sulla mia vita professionale, non intendo annoiare nessuno con cose che possono interessare solo me. Mi sembrerebbe patetico».
– Lei è orgogliosamente partenopeo. Immagino che avrà riflettuto ogni tanto sulla napoletanità, sulla visione della vita che ha la gente partenopea, sulla sua filosofia che spesso viene citata nelle sue declinazioni proverbiali o sapienziali. Se dovesse indicare il più grande pregio e il più grave difetto dei napoletani, quali indicherebbe?
«È vero, sono orgogliosamente napoletano, ma non approvo tutte le forme di oleografia e sviolinamento. Sui pregi e difetti dei miei concittadini mi piace ricordare una vecchissima espressione, probabilmente non originale, del campione di calcio Josè Altafini il quale, intervistato dalla Rai sulla sua terrazza con vista sul golfo di Napoli, spiegava come, nel bene o nel male, il napoletano sia comunque esagerato: o estremamente perbene e signorile oppure perdutamente cafone se non delinquente.
Ritengo che questo sia vero e che discenda dalla nostra storia, fatta di grandi re ed esponenti della nobiltà particolarmente illuminati, ma anche di una vastissima plebe lasciata per secoli nella miseria e nell’ignoranza: non è un caso che a Napoli vi sia tuttora un vasto sottoproletariato senza che ci sia un proletariato!».
– Concludendo…
«Concludendo, quello che mi manda in bestia del mio popolo è la sua volontaria subalternità, essendosi trasformata Napoli in una provincia di Roma o addirittura di Milano: avete fatto caso alla circostanza che, pur essendo Napoli e la Campania da sempre terra fertile di musicisti, scrittori, registi, attori, artisti di ogni genere, quasi tutti questi illustri personaggi, con l’eccezione (fino a quando?) di Maurizio De Giovanni, vivono e lavorano in altre città del centro nord? È vero o non è vero che a Napoli o comunque in Campania non esiste una casa di edizioni musicali di livello nazionale in grado di valorizzare i talenti locali?». (giornalistitalia.it)
Mario Nanni



















 CONVENZIONI
CONVENZIONI