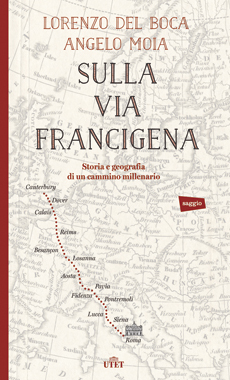ROMA – Il “caso Pantano” e l’assurda accusa a suo carico, quella di “ricettazione” di notizie, sono diventati una tesina che è valsa ad Aurelia Zucaro, 27 anni, di Cosenza, il superamento dell’esame di Stato da giornalista professionista. S’intitola, appunto, “Ricettatori di notizie” – sottotitolo: “L’ultimo reato bavaglio contro la tutela del segreto professionale” – il lavoro che la giovane calabrese ha portato all’attenzione della Commissione esaminatrice.
Di tutto rispetto il curriculum della neo professionista: con in tasca una laurea in Editoria e Nuove professioni dell’editoria conseguita a 22 anni, nel 2010, all’Università La Sapienza di Roma e una collaborazione con Il Quotidiano della Calabria, Aurelia ha preso il volo per gli Stati Uniti, dove è rimasta a lungo, svolgendo il praticantato ad America Oggi, giornale che esce abbinato a Repubblica. Poi, il ritorno nella sua terra e la soddisfazione di portarne alla ribalta le difficoltà, certo, ma anche quello spirito combattivo e tenace che spicca nella brava gente di Calabria. Costretta a faticare il doppio, specie in certi ambiti professionali, quali il giornalismo, per rimarcare il sacrosanto diritto a fare semplicemente e onestamente il proprio lavoro.
Riportiamo, di seguito, la tesina di Aurelia Zucaro, realizzata, come scrive lei stessa, prendendo spunto dalla notizia del “caso Pantano” data dal nostro giornale:
“Ricettazione”. È il reato contestato al giornalista Agostino Pantano, all’epoca dei fatti responsabile della redazione di Gioia Tauro per il quotidiano “Calabria Ora”. L’accusa è di aver pubblicato, nel 2010, un documento “riservato e ottenuto illecitamente”: la relazione della commissione d’accesso, che avrebbe portato al decreto di scioglimento del consiglio comunale di Taurianova per condizionamenti mafiosi.
Ne danno notizia lo scorso 5 marzo il portale d’informazione tematica “Giornalistitalia.it”, il “Fatto quotidiano” e il sito di Franco Abruzzo (storico presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia), come aggiornamento alle ricerche e pubblicazioni in tema di tutela del segreto professionale.
La vicenda, in effetti, ha dell’incredibile.
La Procura di Palmi ha accusato Pantano di aver acquisito a pagamento atti coperti da segreto istruttorio, per averne un profitto personale. È qui che risiede la chiave del reato di ricettazione: “il profitto personale”. Ma un giornalista che pubblica notizie non ne ricava un profitto diretto, essendo queste l’oggetto del suo lavoro quotidiano per cui verrà comunque pagato.
Il “profitto”, se mai, è dei lettori che vengono così a conoscenza di fatti, altrimenti ignoti, utili a formare l’opinione pubblica nell’ottica di un migliore esercizio della cittadinanza attiva.
Insomma, la pubblicazione di quegli articoli (sono sette quelli incriminati) rientrava “nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica politica”, come già pronunciato il 17 ottobre 2011 dal gip del Tribunale di Cosenza, Enrico Di Dedda, nell’accogliere la richiesta di archiviazione delle indagini, seguite alla querela per diffamazione da parte dell’ex sindaco di Taurianova, Rocco Biasi. Lo stesso gip, tuttavia, trasmetteva gli atti alla procura per chiedere di indagare il giornalista per ricettazione. Per questo, Agostino Pantano dovrà presentarsi a processo il 16 aprile prossimo e rischia fino a otto anni di carcere.
L’accusa è arrivata dopo aver rifiutato di svelare la fonte delle sue informazioni.
La procura ha ipotizzato quindi che quegli atti fossero stati trafugati illegalmente dal giornalista, piuttosto che essergli stati forniti da qualcuno che ne era legittimamente in possesso.
Racconta Pantano al giornalista del “Fatto”: «Se quando mi hanno interrogato avessi detto una bugia, io oggi non sarei sotto processo e lo sarebbe chiunque avessi indicato come il mio rifornitore di refurtiva».
Sull’episodio è intervenuto anche il segretario calabrese di Fnsi, Carlo Parisi, sollecitando il Parlamento a intervenire nei confronti della nuova “variante” rappresentata dalla ricettazione di notizie: «Un reato assurdo per una professione deputata a riferire ai cittadini notizie, naturalmente vere, seppur scomode, che lapalissianamente (per essere tali) finiscono sempre per dar fastidio a qualcuno».
Non ci sarebbe però bisogno di interpellare il Parlamento, se solo pubblici ministeri e giudici applicassero le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 348-349/2007 e n. 39/2008 (“Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu”).
Sono trascorsi quasi vent’anni dalla epocale sentenza Goodwin (Corte europea dei diritti dell’Uomo, 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron), con cui la Corte di Strasburgo riconosceva al giornalista il diritto di ricercare le notizie e che di tale diritto fosse “logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche”.
La sentenza richiamava la violazione dell’articolo 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione e il diritto a essere informati, e poneva le basi per le successive pronunce che negli anni a venire avrebbero trattato più a fondo la questione della salvaguardia del segreto professionale del giornalista.
Nel 2003 con la sentenza Roemen e nel 2007 con la sentenza Tillack, la Corte impone l’alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a tutela delle fonti personali.
Ancora, nel 2007, la vicenda Dupuis contro Francia (ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007), sancisce la prevalenza del diritto di informare sulla protezione del segreto istruttorio, soprattutto quando questo rivesta notizie di preminente interesse pubblico. Lo stesso interesse, verrebbe da dire, che comporta per i cittadini di un comune la notizia di sospette infiltrazioni mafiose, tali da indurre il Presidente della Repubblica a emanare un decreto di scioglimento del consiglio comunale.
Nella sentenza del 2007 emergeva un aspetto cruciale a scagionare i giornalisti dall’accusa di rivelazione di segreto istruttorio, cioè “l’onere della prova”: non tocca ai giornalisti dimostrare che non hanno violato il segreto istruttorio, ma spetta alle autorità nazionali provare in quale modo “la divulgazione di informazioni confidenziali può avere un’influenza negativa sulla presunzione di innocenza di un indagato. In caso contrario, la protezione delle informazioni coperte da segreto non è un imperativo preponderante”.
Per il giornalista calabrese la pubblicazione di quelle informazioni non poteva costituire violazione del segreto istruttorio, dal momento che quegli atti ebbero effetti amministrativi evidenti a tutti. Il reato che allora gli viene contestato è quello di essere il ricettatore di un furto il cui autore non è ancora stato trovato. A meno che l’imputazione non cambi e venga lui stesso accusato di essere il ladro. E anche in questo caso, come per il reato di diffamazione o quello di rivelazione del segreto istruttorio, la pena massima (tre anni di carcere) sarebbe più lieve.
Aurelia Zucaro











 CONVENZIONI
CONVENZIONI