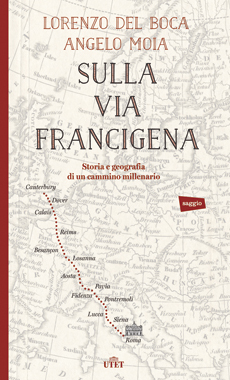ROMA – «Non siamo eredi, non lasciamo eredi. Non ereditiamo niente da nessuno, non lasceremo eredità di niente a nessuno. È questa, per dirla in breve e in modo diretto e brutale, la fotografia della nostra condizione oggi. Ogni vita è un fatto a sé. La sconnessione dal prima e dal poi riguarda in varia misura e a vari livelli di consapevolezza ciascuno di noi, nella vita personale e in quella pubblica e sociale.  Anche la politica schiva o rinnega le eredità. Restano in politica come nel commercio marchi inanimati e sbiadite icone, ma nulla che somigli a un’eredità. Per la prima volta nella storia dell’umanità, o almeno della storia a noi nota, viviamo in un’epoca senza eredi. O quantomeno è la prima a non riconoscere alcuna eredità come valore da custodire e da trasmettere».
Anche la politica schiva o rinnega le eredità. Restano in politica come nel commercio marchi inanimati e sbiadite icone, ma nulla che somigli a un’eredità. Per la prima volta nella storia dell’umanità, o almeno della storia a noi nota, viviamo in un’epoca senza eredi. O quantomeno è la prima a non riconoscere alcuna eredità come valore da custodire e da trasmettere».
Marcello Veneziani racconta così il suo ultimo libro, “Senza eredi” (Marsilio Editori, 336 pagine, 19 euro) e lo fa con la leggerezza del poeta e del filosofo quale egli è, poeta di grande carisma e testimone del suo tempo come pochi altro sanno esserlo, leggiadro e sublime insieme. «Per una sera – sottolinea Pierluigi Roesler Franz – abbiamo sognato con lui e ci siamo emozionati con le cose che ci ha raccontato a Villa Glori, serata affascinante e avvolgente, assolutamente da ripetere».
Questo libro è un pugno nello stomaco, ma pieno di mille verità e di mille emozioni diverse, che attraversano intere generazioni, e che Marcello Veneziani trasmette ai suoi lettori come monito e ricerca di futuro. Solo lui sa fare bene queste cose.
Lo ha detto meglio di tutti a Villa Glori il presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, Federico Mollicone, nella serata di presentazione del libro organizzata dal presidente dell’Associazione identità e confronti, Giancarlo Elena, alla quale hanno partecipato il segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi, il componente della Giunta Esecutiva, Pierluigi Roesler Franz, e la giornalista di Rai Radio 1 Alessandra Rauti.
«Ogni vita finisce su un binario morto, non proviene da nessun luogo e non continua da nessuna parte. Benvenuti nella società senza eredi. Non resta che confidare nell’imprevisto, nell’ignoto, nella pietà, nei tornanti. O nel miracolo di imprecisati déi».
La nostra è, dunque, la prima epoca senza eredi. Non riconosciamo eredità ricevute e non lasceremo eredità da trasmettere. Nessuno continuerà l’opera, nessuno salverà quel che poteva e doveva essere salvato. Non lasceremo tracce. Il tempo non è galantuomo ma smemorato: non renderà giustizia. Ma come se ne esce?
Marcello Veneziani è diretto e sornione insieme. Per reagire a questa amnesia, o cancellazione ed emorragia, e salvare il salvabile, lo scrittore pugliese ha composto una raccolta di settanta miniature di saggi, succinte biografie, profili non convenzionali, in vari casi sconvenienti, quasi 400 pagine fitte come un uovo, e un indice infinito di nomi e di riferimenti bibliografici.
Da Platone a Sant’Agostino, Marsilio Ficino e Raffaello Sanzio, da Pascal a Vico, da Leopardi a Manzoni, da Baudelaire a Proust e a Kafka, da Vattimo a Ratzinger, fino ai pensatori e agli scrittori più vicini a noi e viventi. Prima di loro, a essere senza eredi – ricorda lo scrittore – sono i classici, i grandi del passato, cancellati o abbandonati, quando non maledetti.
Riflessioni amare, pesanti, ricorrenti in ogni famiglia, che sono parte della storia di ognuno di noi, ma a cui ognuno di noi forse preferisce non pensare.
«Dopo di noi – sottolinea Marcello Veneziani – nessuno continuerà la nostra opera, nessuno salverà qualcosa della nostra eredità; non lasceremo tracce, tutto sarà cancellato dall’acqua e dal vento. L’acqua dell’oblio che cancella ogni orma e il vento della rimozione che spazza ogni cosa».
Ma come è possibile che sia questa la verità dei nostri tempi?
Per il grande Marcello Veneziani tutto questo è il coerente epilogo di «una società senza padre, poi diventata società senza figli, una società parricida e infanticida, all’insegna delle orfanità elettive. La società dei mutanti e dei nonati, per via della denatalità e dell’aborto. L’epoca del nichilismo alla fine mantiene la promessa: di tutto resterà niente, dopo di noi il nulla».
Lo scrittore si trasforma in filosofo dell’esistente, antropologo sociologo e analista insieme, che arriva finanche a commuovere il foltissimo pubblico in sala.
Parte dalla domanda lo scrittore-filosofo: «A chi lasci i tuoi beni, il tuo patrimonio di vita, spirituale e reale, la tua biblioteca, il tuo archivio di ricordi, oggetti e pensieri?».
La risposta è più forte della domanda: «Ai topi e agli inceneritori».
Dio mio quante verità in questo libro! che vi consiglio caldamente di leggere, e se posso andare oltre, che vi consiglio di regalare ai vostri figli, se ne avete o alle vostre compagne, perché forse lo sfogo reale di questo meraviglioso poeta dei giorni nostri potrà aiutarli a salvare quel poco che avete da lasciare dopo di voi.
Un patrimonio piccolo o grande che sia – evidenzia Marcello Veneziani – che verrà quantificato e svenduto: «Se privo di valore economico occorrerà disfarsene nel modo più rapido e indolore, sarà un’opera da svuota cantine o da wc chimico. Dovrà svanire senza lasciar traccia di sé. Lo statuto di eredi vale finché si è dal notaio, ovvero fino alla commutazione delle intenzioni testamentarie in beni da usufruire. In ogni campo ha valore positivo ciò che non è ereditato e non lascia eredità, ciò che è nuovo, senza precedenti o destinato a sorpassare e far dimenticare ogni antefatto».
Ma questo vale in ogni campo? Vale anche in politica? Veneziani sorride, con questa sua smorfia accattivante e da vecchio saggio di paese, e rotola altri massi dalla montagna.
«In politica – sorride amaramente – ogni leader e ogni movimento deve presentarsi come nuovo, deve effettuare radicali restyling che sono un periodico disfarsi delle eredità per apparire più adeguati al presente e meno gravati da scheletri nell’armadio, ingombranti eredità da cancellare. Nuove app ci attendono, non è più tempo di mantenere le vecchie. La storia in sé è un peso insopportabile. La tecnica ci dispone di continuo verso l’aggiornamento».
Questo, tradotto in parole più semplici, significa disconoscere i maestri, perché «non ci sentiamo eredi e continuatori della loro opera e della loro lezione, non hanno da insegnare nulla perché provengono da tempi arretrati rispetto al nostro, con tecnologie decisamente superate. Nessun abitatore del passato può guidarci nel futuro o insegnarci qualcosa di adeguato al mondo che verrà».
Bellissimo questo passaggio, leggiamolo insieme: «Del passato – scrive Marcello Veneziani – viene salvata solo la memoria delle vittime, però non è un’eredità da salvaguardare e da continuare, ma vale a contrario come un monito per non ripetere quegli e/orrori. La memoria delle vittime è un atto d’accusa e di rigetto dell’eredità dei carnefici».
Amarissimo lo specchio sociale che Veneziani ci racconta e ci mette tra le mani. Lo scrittore parla di un modo dove non si fanno più figli: «Se ci sono partono, lasciano la casa e la città familiare, cambiano orizzonte. E se non partono si diseredano da soli, si allontanano con la mente e col cuore, reputano che vivere sia emanciparsi da chi li ha messi al mondo. Non mancano eccezioni, e non sono neanche rare; ma la tendenza generale, lo spirito del tempo, è quello. Niente eredi. I paesi si svuotano, non c’è ricambio, le famiglie sono sull’orlo dell’estinzione dalla denatalità e dall’emigrazione; presenze secolari spariranno nel volgere di pochi decenni; al più resterà dispersa nell’altrove una spaesata disseminazione».
Di conseguenza, non vale più la pena ricordare, o peggio nutrire nostalgia del passato e di chi non c’è più: «Tempo perso, vano esercizio, grottesco spiritismo contro il procedere ineluttabile della vita.
Anche per questo – scrive Marcello Veneziani – si interrompe la trasmissione di saperi, principi, pratiche, consuetudini, esperienze: tutto ciò un tempo si chiamava tradizione, era fondata su un principio di eredità biunivoca, ossia ricevuta e consegnata, che sintetizzo nello status di “eredi gravidi”.
Il passato è privo di valore e significato, va cancellato, rimosso, maledetto, superato; tutto è accelerato, meccanizzato e sostituito. Non si trattiene nulla, tantomeno il senso della continuità».
Solitudine, tristezza, vuoto esistenziale, sembra un libro scritto da un uomo su cui pesa un passato di rinunce, eppure questo libro è insieme anche è una esaltazione del bello, e del meglio del nostro vissuto, e quindi uno stimolo a rifuggire dalla realtà che Marcello Veneziani perché una società cosi immaginata e concepita, o meglio costruita, è una società che porta alla morte dell’uomo e all’annullamento di tutto ciò in cui per tutta una vita abbia creduto.
«Nonostante tutto – conclude Veneziani – noi continueremo a sentirci eredi di autori e tradizioni e a onorare i maestri, i padri, i fratelli maggiori. E, se saremo soli, vuol dire the saremo in compagnia degli dei, degli assenti, degli invisibili». Un libro semplicemente meraviglioso e bellissimo. (giornalistitalia.it)
Pino Nano
CHI È MARCELLO VENEZIANI
Marcello Veneziani è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Giornalista professionista iscritto all’Ordine del Lazio dal 18 febbraio 1982, proviene da studi filosofici. Ha fondato e diretto riviste tra cui L’Italia Settimanale e Lo Stato. Ha scritto su vari quotidiani e settimanali: dal Corriere della Sera a La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Messaggero, Panorama.
Ha scritto a lungo su Il Giornale, chiamato da Montanelli e poi da Feltri, dove ha tenuto per anni la rubrica in prima pagina Cucù. È commentatore della Rai.
Ha scritto vari saggi tra i quali La rivoluzione conservatrice in Italia, Processo all’Occidente, Comunitari o liberal, Di Padre in figlio. Elogio della Tradizione, La cultura della destra e La sconfitta delle idee (editi da Laterza). I Vinti, Rovesciare il ’68, Dio, Patria e Famiglia. Dopo il declino (editi da Mondadori).
È poi passato a temi esistenziali pubblicando saggi filosofico letterari come Vita natural durante dedicato a Plotino e La sposa invisibile, un viaggio carnale e metafisico tra le figure femminili. Per Mondadori ha pubblicato tra l’altro Il segreto del viandante, Amor fati, la vita tra caso e destino, Vivere non basta. Lettere a Seneca sulla felicità.
L’ultimo suo libro, uscito da Mondadori, è Anima e Corpo. Viaggio nel cuore della vita. Per gli Oscar Mondadori è in libreria Ritorno a Sud. Ha poi pubblicato con Marsilio Lettera agli italiani (2015), Alla luce del mito (2016), Imperdonabili. Cento ritratti di autori sconvenienti (2017), Nostalgia degli dei (2019) e Dispera bene (2020). Inoltre Tramonti (Giubilei regnani, 2017) e Dante nostro padre (2020), La Cappa (2021), Scontenti (2022).










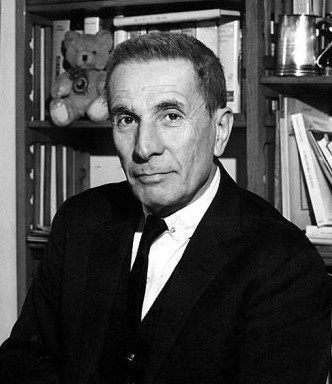









 CONVENZIONI
CONVENZIONI