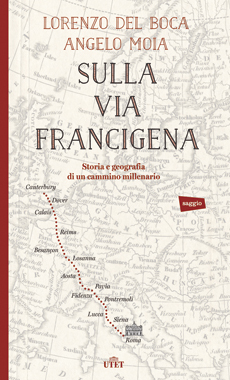ROMA – Francesco Saverio Vetere è il segretario generale dell’Uspi, l’Unione Stampa Periodica Italiana, quello che nel complesso e variegato panorama dell’informazione generale di questo Paese, rimane oggi una “cellula viva” della grande stampa italiana. E in questo ruolo, è la testa di ponte di almeno tremila giornali italiani diversi, piccoli o grandi che sia poco importa, e che a volte fanno a pugni per sopravvivere, per emergere, per liberarsi dalla precarietà a volte assillante del sistema e del momento politico. Bene, dietro ognuno di loro, c’è “l’avvocato”, come ormai da anni lo chiamano molti dei suoi associati.
 Parlare di Uspi significa parlare di un’associazione che dal 1953 riunisce insieme ben mille editori, almeno 3000 mila testate periodiche diverse, alcune di queste oggi anche telematiche, edite o trasmesse con qualunque mezzo da medie e piccole imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit, e che appena un anno fa, lunedì 19 giugno del 2023, a Palazzo Madama, Senato della Repubblica, hanno celebrato il loro primo settantesimo compleanno di vita. E 70 anni di stampa periodica in Italia sono in realtà la storia vera del Paese e della Repubblica. Una storia importante arricchita lo scorso anno dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Uspi con Figec Cisal per il lavoro giornalistico e la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione.
Parlare di Uspi significa parlare di un’associazione che dal 1953 riunisce insieme ben mille editori, almeno 3000 mila testate periodiche diverse, alcune di queste oggi anche telematiche, edite o trasmesse con qualunque mezzo da medie e piccole imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit, e che appena un anno fa, lunedì 19 giugno del 2023, a Palazzo Madama, Senato della Repubblica, hanno celebrato il loro primo settantesimo compleanno di vita. E 70 anni di stampa periodica in Italia sono in realtà la storia vera del Paese e della Repubblica. Una storia importante arricchita lo scorso anno dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Uspi con Figec Cisal per il lavoro giornalistico e la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione.
L’uomo è un “duro”, chi lo conosce bene parla di un professionista educato a lavorare per gli altri anche 14 ore al giorno, senza un’ora di sosta, cocciuto e caparbio come solo certi calabresi sanno ancora esserlo, un uomo colto, avvocato cassazionista, giornalista pubblicista, giurista abituato a navigare in mari procellosi, professore e filosofo insieme, un intellettuale pragmatico che non teme mai nessun confronto con gli altri.
Questo fa di lui un leader a 360 gradi, amato e seguito dal “popolo Uspi” più di quanto non si immagini, con in corpo la giusta rabbia per le lobby di potere, e nemico dichiarato di chi vorrebbe controllare o influenzare l’indipendenza della stampa periodica italiana. Un mastino vero e proprio, intelligente, sornione, guardingo, riservato, attentissimo alla forma, un cane da guardia come pochi, e soprattutto un uomo intellettualmente libero.
“Il Re del mondo” è il titolo che Francesco Saverio Vetere, ha scelto per il suo nuovo romanzo, già su Amazon, e dentro il quale c’è per intero il senso della sua vita, della sua giovinezza, della sua esperienza di grande comunicatore e di testimone del suo tempo. Una sorta di favola moderna che racconta di nove ragazzi coetanei che crescono insieme in un piccolo paese e che vengono educati alla filosofia fin da piccoli da un giovane maestro. Ma l’educazione al pensiero filosofico non consente loro di accettare senza critiche le convinzioni comuni del loro paese.
Mettono dunque in discussione dapprima cose molto piccole, poi il senso stesso delle credenze fondamentali della società nella quale vivono. Quindi costruiscono leggende anche su storie passate, ispirandosi al principio della ricerca come caratteristica fondamentale dell’essere umano.
Quando il loro maestro Guido parte per andare a insegnare all’estero i ragazzi continuano il loro percorso di crescita. Sette di loro rimangono nel paese e mantengono un legame molto forte, incontrandosi a volte di notte nella casa di uno di loro. Degli altri due, uno parte per studiare all’università e in pratica non torna più ad abitare in paese. L’altro si trasferisce nel capoluogo e fa una vita molto appartata. Rimane, però, il fortissimo legame tra di loro e una vicinanza che non viene mai meno, anche solo in senso spirituale.
Una storia quanto mai avvincente, ma soprattutto una riflessione generale sulla vita, commovente, coinvolgente, a tratti anche ossessiva.
Una sera di Capodanno, i sette si riuniscono senza un motivo apparentemente valido per stare lontani dalle famiglie. Ricostruiscono tutta la loro vita fino a quel momento e parlano del loro maestro, Guido, della sua vita, del suo incontro con loro, della filosofia e del suo insegnamento.  Raccontano del suo amore per una donna più grande di lui e delle vicende che lo portarono ad andare all’estero ad insegnare. Quel loro maestro sarebbe diventato un personaggio molto importante e famoso, sempre con un fondo di amarezza perché la sua partenza lo aveva portato a rinunciare all’amore della donna che amava.
Raccontano del suo amore per una donna più grande di lui e delle vicende che lo portarono ad andare all’estero ad insegnare. Quel loro maestro sarebbe diventato un personaggio molto importante e famoso, sempre con un fondo di amarezza perché la sua partenza lo aveva portato a rinunciare all’amore della donna che amava.
Il mattino seguente, molto presto, i sette si muovono verso il cimitero e lì si riuniscono agli altri due. Uno di loro porta con sé l’urna con le ceneri di Guido e tutti insieme gli rendono l’estremo omaggio e depositano l’urna nella piccola cappella di famiglia.
Ormai tutti hanno superato i sessant’anni e hanno gradualmente preso coscienza di sé stessi.
– Professore, sbaglio o la storia di questi nove ragazzi è piuttosto un viaggio alla scoperta del mondo, ma soprattutto alla ricerca di Dio?
«Dentro questo libro troverete, almeno spero, il cammino di conoscenza in cui consiste la vita di ogni uomo, la filosofia, la religione, i misteri. Certo, anche la ricerca di Dio e il senso della vita. Il senso della storia, anche la più piccola narrata. Marcellino che è il protagonista del romanzo incarna l’archetipo del pellegrino. Lui vive e va avanti con passi non rivolti a una meta ultima e definita, ma tesi a comprendere tutto quello che ruota attorno alla sua vita.
È un viandante del nostro tempo, aperto, senza schemi precostituiti, un uomo assetato di conoscenza, esploratore della vita e di ciò che potremmo chiamare il “divino”. Vede, l’idea di possedere una singola verità gli è del tutto estranea. Lui invece intuisce che la conoscenza, più che un possesso, è un mosaico da ricomporre giorno per giorno, istante dopo istante».
– Ho trovato suggestive le pagine i cui lei racconta l’arrivo di Marcellino a Roma, e che davanti alla maestosità della Basilica di San Pietro si chiede se quella Chiesa possa davvero essere considerata la reggia del “Re del Mondo” …
«Mi piacerebbe molto che questa pare del mio libro venisse letta come una mia riflessione intima sulla crisi del senso del sacro. Osservando l’imponenza della Basilica, in realtà Marcellino non percepisce una sensazione di conforto, di pace interna, ma al contrario, lui avverte uno strano vuoto. L’architettura sacra voleva rendere tangibile la gloria del divino, ma tuttavia, in un’epoca in cui molti faticano a sentire Dio nei luoghi canonici, l’involucro esterno, chiamiamolo così, rischia di sembrare privo di sostanza. Per Marcellino, invece, la sacralità è ovunque si riconosca la presenza del divino. Lo è nelle persone, nelle culture, nelle prospettive del mondo».
– Salvatore, invece, altro protagonista del romanzo, è completamente diverso e lontano da Marcellino. Perché?
«Salvatore simboleggia la lotta quotidiana contro la pesantezza della storia, contro tutto ciò che ci precede e ci condiziona.  A differenza di Marcellino, che si apre alla scoperta, Salvatore è segnato dalle vicende dolorose che ha vissuto, la perdita dei compagni, il carico di colpe e responsabilità, ma anche lui alla fine mira a una forma di redenzione. La redenzione di cui parlo non va intesa come un riscatto filosofico o mistico, ma come qualcosa di estremamente concreto e complesso, fatto di lavoro, fatica, soprattutto dedizione. Salvatore si adopera per edificare, aggiustare, rimettere in sesto tutto ciò che è infranto, e il suo corpo finisce per cedere sotto il peso della materia. La morte di Salvatore evidenzia l’ineludibile limite di chi tenta di domare e controllare il mondo con le sue sole forze. Alla fine del suo viaggio Salvatore ritrova una pace interiore: egli capisce che il passato, con tutto il suo carico di sofferenza, non si cancella, bensì si tramanda. E nel chiedere che la storia dei suoi compagni venga narrata a Pietro risiede la chiave del suo lascito: non si costruisce alcuna vera conoscenza senza tenere viva la memoria».
A differenza di Marcellino, che si apre alla scoperta, Salvatore è segnato dalle vicende dolorose che ha vissuto, la perdita dei compagni, il carico di colpe e responsabilità, ma anche lui alla fine mira a una forma di redenzione. La redenzione di cui parlo non va intesa come un riscatto filosofico o mistico, ma come qualcosa di estremamente concreto e complesso, fatto di lavoro, fatica, soprattutto dedizione. Salvatore si adopera per edificare, aggiustare, rimettere in sesto tutto ciò che è infranto, e il suo corpo finisce per cedere sotto il peso della materia. La morte di Salvatore evidenzia l’ineludibile limite di chi tenta di domare e controllare il mondo con le sue sole forze. Alla fine del suo viaggio Salvatore ritrova una pace interiore: egli capisce che il passato, con tutto il suo carico di sofferenza, non si cancella, bensì si tramanda. E nel chiedere che la storia dei suoi compagni venga narrata a Pietro risiede la chiave del suo lascito: non si costruisce alcuna vera conoscenza senza tenere viva la memoria».
– Ricapitoliamo, Marcellino rappresenta l’uomo e Salvatore il mondo, ma c’è anche Pietro nel suo racconto…
«Pietro è il custode dell’interrogazione perpetua».
– Cosa significa?
«Nel romanzo, Dio non appare come una risposta esaustiva, ma come una continua domanda che emerge al termine di ogni cammino e di ogni viandante. Quando Pietro parla, non offre soluzioni, bensì spinge chi ascolta ad avvertire ancora più intensamente il mistero di Dio».
– Quando Pietro immagina Dio, come lo vede?
«Il Dio di Pietro non è un’entità definita, un dogma o un’autorità che impartisce ordini. È presente nell’assenza, nelle parole che rimettono tutto in questione. Pietro testimonia una dimensione divina che non si impone con risposte definitive o assolute, ma che spalanca invece spazi di riflessione e di silenzio. Quando Franz, in punto di morte, si ritrova sul confine tra i mondi, la voce di Pietro non chiude il cerchio, ma lo riapre, ribadendo l’inesauribilità del mistero».
– Ma chi è in realtà il Franz di cui lei parla?
«Franz è una figura enigmatica, una sorta di “supervisore” che, alla fine della sua vita, affronta il momento decisivo. Franz è una persona che, per lungo tempo, ha creduto di poter influenzare gli accadimenti senza mai esporsi, agendo da dietro le quinte. Ma nell’ora suprema, quando si confronta con la morte, ecco allora che si rende conto che quel suo potere era del tutto illusorio».
– Ho trovato il racconto della morte che arriva alla sua porta di grande suggestione…
«Nulla può sostituire l’incontro con la morte che arriva. Lo è per ogni uomo. Nel momento in cui la morte bussa alla nostra porta tutto ciò che si è accumulato nella vita — potere, conoscenza, influenza, prestigio — tutto viene meno».
– Cosa rimane, Professore?
«Resta solo la nudità di un uomo di fronte all’ignoto. E la voce divina, se vogliamo chiamarla così, non pronuncia né decreti né consolazioni. Pone solo domande. Proprio in questa tensione si compie il passaggio più autentico verso la consapevolezza».
– Ad un certo punto del suo racconto Pietro è artefice di un “miracolo” molto singolare. Come va letta questa pagina?
«Nel romanzo, il miracolo non è una manifestazione eclatante di poteri soprannaturali. È, piuttosto, un atto di amore umano capace di generare redenzione e riconciliazione. Un gesto semplice che muta il corso degli eventi, alleviando il dolore di Salvatore, e offrendo una speranza laddove sembrava mancare. Questa dinamica rivela che l’autentica trasformazione dell’uomo scaturisce dalla solidarietà, dalla compassione, dalla volontà di entrare in empatia con le ferite dell’altro. Non è qualcosa di calato dall’alto, ma è il frutto di un incontro di sguardi e di cuori».
– C’è anche tanto di Gesù nel suo libro?
«Gesù è colui che cammina costantemente al fianco di Marcellino, senza imporre dottrine o sentenze. Gesù rappresenta l’idea di una presenza divina che è vicina all’uomo, che vive accanto a lui, che lo segue, che lo sostiene nei momenti di maggiore smarrimento. Non si tratta di un principio o, peggio ancora, di una idea lontana da lui, ma di un vero e proprio compagno di viaggio che ricorda a Marcellino — e a ciascuno di noi — la possibilità di trovare il sacro in ogni tappa del nostro cammino».
– Posso definire il suo romanzo un viaggio nella fede?
«Posso dire solo che nel romanzo convivono aspetti tangibili del nostro tempo, la quotidianità, il lavoro, la fatica di vivere, e un continuo slancio verso l’oltre, un interrogarsi, cioè sui fondamenti della realtà che talvolta può apparire “un fatto magico”. Mi creda, non ho mai cercato volontariamente di rientrare in una determinata scuola o movimento letterario: la verità è che la mia storia ha preso forma attorno ai personaggi del romanzo, alle loro domande, e soprattutto ai loro conflitti».
– Possiamo pensare ad una sorta di realismo magico?
«Se i lettori dovessero ravvisarvi elementi del realismo magico, potrei anche capirlo. C’è in tutto quello che ho scritto una dimensione del divino che affiora prepotentemente nel quotidiano, senza grandi proclami, quasi fosse una componente naturale della nostra esistenza. Se altri, invece, preferissero parlare di realismo metafisico – qualcuno me lo ha anche detto – riconoscendo una tensione filosofica più marcata, accetterei di buon grado anche questa chiave interpretativa. In ogni caso, l’aspetto fondamentale che mi piacerebbe venisse colto dalla lettura di queste pagine è l’incontro sostanziale tra lo sforzo di comprensione umana e il senso di mistero che costella la nostra vita».
– Nel suo libro, lei racconta della formazione di nove ragazzi guidati da un maestro, Guido Grimaldi, che li introduce al metodo filosofico…
«Il libro si concentra proprio sulla crescita di questi giovani, sulla loro scoperta del pensiero critico, e su come un maestro possa segnare il percorso esistenziale di chi lo segue.
Guido Grimaldi è una figura carismatica, un mentore che non si limita a trasmettere nozioni, ma invita i ragazzi a interrogarsi su ciò che dà senso alla vita. In quel contesto, affiora forte il tema dell’amore come forza che conferisce pienezza all’esistenza. L’amore non come un sentimento episodico, ma l’amore come qualcosa che pervade e sostiene l’intera ricerca umana. Questo nucleo concettuale si ripresenta poi anche in “Il Re del Mondo”, perché i personaggi, pur trovandosi di fronte a sfide più complesse, portano in sé l’imprinting di quella formazione iniziale, che li ha aperti al dialogo, alla memoria condivisa e alla trascendenza. L’amore, in definitiva, funge da filo conduttore che unisce le due opere e sostiene la narrazione fino al suo epilogo».
– Non glielo ho chiesto prima, ma non posso non farlo ora, “Il Re del Mondo” è in qualche modo la sua autobiografia?
«Chi scrive sa bene che in fondo ogni opera letteraria è sempre un riflesso concreto di chi la scrive, ma questa non lo è più delle altre. Ogni autore riversa nei propri personaggi e nelle proprie pagine frammenti di sé, delle sue inquietudini e delle sue speranze. Così ho fatto io anche questa volta.
Tuttavia, non esiste una sovrapposizione totale. L’intento semmai rimane quello di raccontare una storia che trascenda la singola esperienza personale, in questo caso la mia vita e la mia storia professionale, e che possa parlare invece, in qualche misura, al resto del mondo, ai miei amici, a chi mi conosce e mi vuole bene, a chi fosse interessato a leggerlo, e che ne colga alla fine la sola certezza che spero venga fuori dalle pagine che ho scritto, e che è la forza dell’amore per la vita e per gli altri. Guai a non credere nell’amore e nella comprensione, e nella condivisione, e nella solidarietà. Che vita sarebbe altrimenti? È negli abissi del dolore che talvolta si trova ciò che sembrava impossibile. Si trova il senso di sé stessi, la strada verso il futuro. Che tutto ciò si chiami fede o intuizione intellettuale dipende dalla nostra formazione, dal contesto in cui viviamo, dalla lingua usata per raccontarci agli altri. Ma non è importante definirla. Bisogna solamente viverla questa fede fino in fondo, attraversando il nulla senza timore». (giornalistitalia.it)
Pino Nano




























 CONVENZIONI
CONVENZIONI