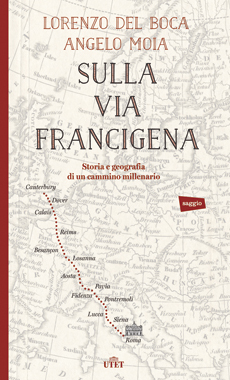ROMA –
Il 18 ottobre 1984 la Cassazione fissò per la prima volta una sorta di “decalogo” cui ogni giornalista doveva attenersi scrupolosamente per evitare una condanna ad un risarcimento danni in sede civile per un articolo ritenuto diffamatorio. Fu una decisione epocale di cui all’indomani riferii per primo sul “Corriere della Sera”.
La notizia ebbe un grande risalto, soprattutto grazie al felice intuito dell’allora capo della redazione romana del quotidiano milanese Antonio Padellaro (poi vice direttore de “L’Espresso” e direttore de “l’Unità” e de “Il Fatto Quotidiano”) perché lo scoop fu pubblicato in 1ª pagina – addirittura in apertura del giornale – e ripreso, nei giorni successivi, sulla stampa italiana ed estera.
Da allora sono trascorsi 30 anni e si é, purtroppo, avverato quanto già si paventava, cioé il via libera al bavaglio della libertà di stampa.
Cercherò di spiegarne in sintesi i motivi.
In Italia si parla di diffamazione sin dall’art. 28 dello Statuto Albertino del 1848.
Ricordo che lo stesso Sindacato dei giornalisti (Aspi – Associazione Stampa Periodica Italiana, poi confluita nell’Associazione Stampa Romana dopo la 1ª Guerra Mondiale) nacque, 137 anni fa, dopo un duello per un articolo ritenuto diffamatorio. La sfida, avvenuta a Roma la sera del 18 maggio 1877, fu vinta dal deputato Augusto Pierantoni (avvocato, deputato radicale per molte legislature e genero del ministro della Giustizia, Pasquale Stanislao Mancini) che, soprattutto grazie alla sua altezza quasi come un corazziere, ferì in allungo all’avambraccio dopo tre attacchi il giornalista del “Fanfulla” Fedele Albanese.
A differenza di altre materie molto meno importanti sulla diffamazione, però, vi é sempre stato molto fumo e poco arrosto. A livello legislativo si sono registrati solo pochissimi interventi, direi quasi con il contagocce. Il 21 febbraio 1948 entrò in vigore la legge sulla stampa (è la n. 47) che consentiva a chiunque si ritenesse leso da un articolo diffamatorio di presentare entro 90 giorni una querela in sede penale. E solo in caso di condanna penale definitiva del giornalista ci si poteva rivolgere alla magistratura civile per ottenere un adeguato risarcimento.
La Cassazione, con la sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della prima sezione civile, redatta dal consigliere Renato Borruso (vedere allegato in calce), rappresentò la svolta, pur in assenza di precise norme di legge. La Suprema Corte aprì, infatti, le porte al giudizio civile di risarcimento danni a prescindere dalla presentazione della querela in sede penale.
In pratica, fu una vera e propria rivoluzione di cui si sono visti i disastrosi risultati: da 30 anni a questa parte si é registrato il graduale crollo delle querele in sede penale sostituite dall’aumento esponenziale delle vertenze civili per risarcimento da diffamazione molte delle quali temerarie perché accompagnate da richieste astronomiche per danni al fine mirato di imbavagliare la libertà di stampa.
Peraltro va ricordato che se un cittadino, che si ritiene diffamato da un articolo, presenta una querela in sede penale che viene poi archiviata o bocciata nel merito dalla magistratura, il giornalista può presentare a sua volta una denuncia penale per calunnia. Viceversa, in caso di azione bocciata dalla magistratura civile, il cittadino presunto diffamato non rischierebbe mai una condanna per calunnia, ma tutt’al più un ristoro delle spese legali e solo in casi rarissimi anche un risarcimento per lite temeraria.
Questa profonda differenza tra penale e civile spiega il boom dal 1985 in poi delle cause civili di diffamazione rispetto alle querele in sede penale.
I maggiori beneficiari della sentenza della Cassazione del 1984 sono stati i magistrati e gli avvocati. I primi rappresentano infatti circa il 50% dei danneggiati in Italia da articoli ritenuti diffamatori sui quali sono poi chiamati a pronunciarsi altri loro colleghi, mentre i secondi hanno difeso in 30 anni in migliaia di cause, da una parte, i presunti diffamati, e, dall’altra, i presunti diffamatori.
Vi sono stati, così, parecchi magistrati ritenutisi diffamati che, pur non perdendo neppure un euro del loro lauto stipendio mensile, hanno ottenuto risarcimenti molto elevati e persino del tutto esentasse (anni fa finì nel cestino la proposta del defunto ex presidente della Corte Costituzionale, Vincenzo Caianiello, di devolvere alle vittime del terrorismo, della mafia, della camorra e della ’ndrangheta gli indennizzi per diffamazione liquidati in favore dei magistrati proprio perché, in concreto, non avevano subìto alcuna decurtazione patrimoniale).
Il tutto condito anche dalla violazione del diritto di difesa sia del giornalista autore dell’articolo ritenuto diffamatorio, sia del direttore responsabile. E ciò dovuto all’incomprensibile differente tempistica prevista: purtroppo dai soli 90 giorni per presentare una querela in sede penale si é, infatti, passati dopo la sentenza della Cassazione del 1984 a ben 5 anni (o addirittura a 10 anni in caso di diffamazione aggravata) in applicazione automatica di una norma del codice civile (l’art. 2947) che era, però, nata per ben altri scopi che non il risarcimento dei danni da diffamazione!
La riforma in Parlamento della diffamazione di cui si parla, ormai, da decenni senza che si approdi mai a nulla di concreto non ha volutamente preso in considerazione le reali problematiche legate ai termini di prescrizione e decadenza.
Nel 2004 il Senato fissò il termine in 1 anno dalla pubblicazione dell’articolo ritenuto diffamatorio (il provvedimento finì poi in un cestino di Montecitorio), mentre il 17 ottobre 2013 la Camera ha fissato la prescrizione in 2 anni dalla pubblicazione dell’articolo ritenuto diffamatorio, termine confermato anche dalla Commissione Giustizia del Senato nel disegno di legge S. 1119, che dal 9 ottobre scorso é all’esame dell’aula di Palazzo Madama.
I nostri moderni soloni non hanno, però, minimamente valutato gli effetti pratici dei termini di decadenza di un giudizio civile per danni da diffamazione rispetto a quelli di una querela in sede penale. E soprattutto non hanno tenuto conto della realtà e del bombardamento di notizie che quotidianamente attraversano il mondo della globalizzazione. E se passa troppo tempo tra l’articolo diffamatorio e la causa civile nessun giornalista è più concretamente in grado di difendersi non avendo più appunti, documenti, nastri, bobine, cd o videocassette e gli stessi giornali ripuliscono periodicamente i loro archivi informatici.
In Parlamento si continua, invece, a dibattere sostanzialmente sull’abolizione del carcere per il giornalista che diffami un cittadino, nonostante questa sanzione sia stata ormai di fatto cancellata dalla Corte Europea di Strasburgo con ripetute sentenze applicabili anche in Italia.
Cercherò, con esempi pratici che mi hanno visto protagonista in prima persona, di spiegare meglio le assurdità del differente termine di 1, 2 oppure di 5/10 anni per l’azione civile di risarcimento danni da diffamazione rispetto ai soli 90 giorni fissati per la querela.
Il sottoscritto parla con un minimo di cognizione di causa, vantando in proposito alcuni record. E’ stato il primo in Italia ad essere citato in giudizio civile per un articolo ritenuto diffamatorio pubblicato 5 anni prima sul “Corriere della Sera” e per lo stesso articolo il primo in Italia a subire un’azione civile di manleva (cioé di rivalsa) da parte del Gruppo Rcs, editore del “Corriere della Sera”, circa 5 anni e mezzo dopo (cioé quasi 4 anni dopo essere stato nel frattempo assunto a “La Stampa”).
Come cronista giudiziario del “Corriere della Sera” scrissi, infatti, il 19 luglio 1983 un articolo (che uscì con la mia sigla) sulla vicenda in Cassazione riguardante il celebre caso Calvi/Ior/Banco Ambrosiano per il quale non ricevetti mai alcuna contestazione né scritta, né verbale.
Il 1° gennaio 1985 passai a “La Stampa”. Il 6 dicembre 1988 ricevetti dall’ufficiale giudiziario un atto di citazione da parte del “Corriere della Sera”, difeso dal compianto avvocato Corso Bovio, in cui mi si comunicava che un legale romano si era ritenuto diffamato dal mio articolo del 19 luglio 1983 e ne pretendeva un adeguato indennizzo dal giornale milanese che egli aveva direttamente chiamato in giudizio con un atto di citazione spedito da Roma il 19 luglio 1988, cioé per la precisione 5 anni esatti dopo la sua pubblicazione.
In pratica, il presunto diffamato, cioé il legale romano, era rimasto in assoluto silenzio, o meglio in letargo, per 5 anni scadenzando come una cambiale al 19 luglio 1988 la richiesta di indennizzo, sperando evidentemente che io avessi perso tutta la documentazione per difendermi. Non si spiega altrimenti un silenzio assoluto durato per 5 anni. Ma nel mio caso, poiché la vertenza inizialmente riguardava solo il legale e il mio giornale di allora, ne fui concretamente informato il 6 dicembre 1988, cioè addirittura quasi 5 anni e 5 mesi dopo.
Nella totale indifferenza del Comitato di redazione del Corriere della Sera (giornale che avevo lasciato ormai da circa 4 anni) e della Fnsi, che sottovalutò del tutto la delicatissima problematica sottostante, che poteva riguardare l’intera categoria, come si è poi puntualmente avverato, mi dovetti difendere da solo con un mio legale, vincendo sempre in tribunale, Corte d’appello e Cassazione.
A distanza di qualche mese lo stesso legale che si era ritenuto diffamato, facendo causa sempre l’ultimo giorno dei 5 anni, vinse invece tutta una serie di cause analoghe nei confronti di colleghi di altri giornali che, a differenza mia, non avevano conservato tutta la documentazione per difendersi. Questi colleghi si videro persino pignorare i loro mobili in casa alla presenza dello stesso legale romano.
Questa vicenda, comune poi a moltissime altre, dimostra che sulla vicenda diffamazione:
1) sono attualmente in vigore 2 assurdi distinti termini di decadenza: da un lato, quello di 90 giorni previsto dalla legge sulla stampa del 1948 per presentare una querela in sede penale e, dall’altro, quello di 5 anni o addirittura di 10 anni per una causa civile di risarcimento danni alternativa all’azione penale, come stabilito nella storica sentenza della Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984 che ritenne applicabile l’art. 2947 del codice civile;
1 bis) il termine di 5 anni o addirittura di 10 anni può, persino, slittare di un ulteriore lasso di tempo per consentire all’editore di rivalersi in giudizio nei confronti del redattore autore dell’articolo ritenuto diffamatorio o del direttore responsabile. Nel mio caso, come ho spiegato prima, la citazione arrivò quasi 5 anni e 5 mesi dopo la pubblicazione del mio articolo;
2) é perfettamente legittima l’azione di manleva dell’editore nei confronti del redattore autore dell’articolo ritenuto diffamatorio o del direttore responsabile. Ciò lede la libertà di stampa perché espone molti direttori e giornalisti in pensione al forte rischio di dover pagare di tasca propria i cittadini diffamati senza che l’editore contribuisca in alcun modo;
3) i risarcimenti liquidati dalla magistratura civile ai cittadini che si ritengono danneggiati sono esenti al 100% da imposta Irpef. Questo beneficio fiscale costituisce un ulteriore stimolo a far causa civile di diffamazione che può, quindi, equivalere ad una vincita al lotto o al superenalotto.
Mi chiedo, però:
a) questi distinti termini di prescrizione tra penale e civile e il possibile lungo lasso di tempo prima di iniziare un’azione civile sono realmente in linea con il diritto di difesa del giornalista?
b) il cittadino che chiede un risarcimento danni da diffamazione in sede civile dopo ben 5 anni di assoluto silenzio va considerato un diffamato o un ricattatore?
c) che rischia il cittadino che perde oggi una causa e non ottiene nulla dal giudice dopo aver chiesto un astronomico risarcimento danni da diffamazione in sede civile con conseguente bavaglio alla stampa?
Posto che a tutti i cittadini, giornalisti compresi, va sempre assicurato il diritto di difesa, come prescrive l’art. 24 della Costituzione, credo che per risolvere correttamente il problema diffamazione, assicurando a tutti un’effettiva parità di diritti vi sia un’unica strada: quella di imporre per l’azione civile un termine di decadenza perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione dell’articolo ritenuto diffamatorio entro cui avanzare domanda di indennizzo almeno per telegramma, fax, raccomandata postale o posta elettronica certificata con contestuale richiesta obbligatoria di adeguata rettifica al direttore del giornale con la stessa evidenza e collocazione dell’articolo ritenuto diffamatorio.
In caso di successiva vertenza civile per mancanza o inadeguatezza di rettifica o di replica alla rettifica che venga contestata, il giudice dovrà prima valutare attentamente caso per caso le diverse responsabilità dell’autore dell’articolo, del direttore e dell’editore e poi pronunciarsi nel merito.
Il drastico accorciamento dei tempi al massimo entro 90 giorni per un’azione civile di risarcimento danni appare perfettamente in linea con la Costituzione perché:
a) il cittadino realmente diffamato dovrebbe avere interesse sin dal primo minuto dopo la pubblicazione dell’articolo a far sapere a tutti di essere stato diffamato ingiustamente. Consentirgli di stare in silenzio per 1, 2 oppure 5 o 10 anni avrebbe, invece, tutto il sapore di mantenergli un ruolo improprio, cioè quello di un ricattatore;
b) ogni giornalista, direttore o editore sarebbe realmente in grado di difendersi in giudizio, in quanto verrebbero di fatto applicati nel giudizio civile, equiparandoli, i 90 giorni già previsti sin dal 1948 per la querela in sede penale.
L’introduzione della rettifica obbligatoria avrebbe il pregio:
a) di tutelare il cittadino, correggendo in tempi rapidissimi una notizia sbagliata o diffamatoria;
b) di estromettere dal giudizio i giornalisti autori dell’articolo se il direttore non pubblicasse poi la rettifica come richiesto o vi replicasse in modo ritenuto scorretto dal giudice;
c) di limitare comunque l’indennizzo che il giudice dovrà liquidare caso per caso se, nonostante la rettifica, fossero comunque derivati danni al cittadino diffamato.
Appare, comunque, evidente che una rettifica immediata e in termini corretti limiterebbe al massimo o persino potrebbe azzerare una richiesta di indennizzo anche astronomica.
Nello stesso tempo – pena segnalazione del caso al Csm – dovrebbe essere imposto al giudice penale, cui pervenga una querela entro i 90 giorni previsti dalla legge sulla stampa del 1948, di informarne immediatamente i giornalisti destinatari come un atto dovuto di garanzia, per consentire loro di esserne subito a conoscenza e di apprestare idonee e tempestive difese ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.
Anche nel settore penale non mancano, infatti, casi assurdi. E, nonostante che le querele per diffamazione vadano presentate per legge entro 90 giorni dalla pubblicazione di un articolo, vi sono Procure della Repubblica che le tengono segretamente in un cassetto anche per circa 7 anni e mezzo, limite entro cui il giudizio penale dovrebbe, comunque, concludersi in via definitiva per non cadere in prescrizione. E’ anche questo un atto arbitrario che confligge apertamente con la legge n. 47 del 1948.
In questi giorni sono stati “festeggiati” i 30 anni anche di un’altra sentenza: é quella del 23 ottobre 1984, emessa appena 5 giorni dopo quella del 18 ottobre, con cui le sezioni unite penali della Cassazione stabilirono che “l’esercizio legittimo del diritto di cronaca – anche sotto il profilo putativo – non può essere disgiunto dall’uso legittimo delle fonti informative” e sottolinearono che non esistono fonti informative privilegiate, tali cioè da svincolare il cronista dall’onere:
1) di esaminare, controllare e verificare i fatti – oggetto della sua narrazione – in funzione dell’assolvimento da parte sua dell’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi;
2) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti esplicati per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in merito a quella verità.
In sostanza il cronista – seguendo i suggerimenti della prudenza e i consigli della perizia professionale – deve esercitare l’insopprimibile diritto di informazione con il rispetto delle norme dettate a tutela della personalità altrui e dell’obbligo inderogabile di salvaguardia della verità sostanziale dei fatti narrati con la lealtà e la buona fede imposte dai doveri che ne qualificano ineludibilmente l’operato.
Solo in questo caso il giornalista non è personalmente punibile per diffamazione, avendo esercitato legittimamente il diritto di cronaca (articolo 51 del codice penale). Viceversa può essere condannato se ha violato i canoni sopracitati riferendo fatti discordanti dalla verità. Questi principi sono stati poi successivamente confermati da altre decisioni analoghe della Suprema Corte.
Pierluigi Roesler Franz
La sentenza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione (18 ottobre 1984, n. 5259)
(omissis) Ciò posto, va ricordato che – come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale – il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:
1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;
3) forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.
I. – La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.
II. – La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.
E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre – con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato – ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):
a) al sottinteso sapiente: cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole – se non apertamente offensivo – nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;
b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;
c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l’uso del punto esclamativo – anche là ove di solito non viene messo – o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, “notevole”, “impressionante”, “strano”, “non chiaro”
d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che … “ riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.










 CONVENZIONI
CONVENZIONI