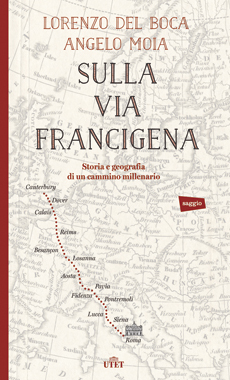ROMA – Decano dei giornalisti italiani, Sergio Lepri è stato autore di libri; formatore di tre generazioni di operatori dell’informazione, forte del suo antico lavoro di insegnante di Storia e Filosofia. Per un trentennio ha diretto l’Ansa, facendone un riferimento cruciale tra le fonti di informazione ufficiali e realizzandovi l’Archivio Dea, punto di forza e fiore all’occhiello dell’agenzia. Lepri è stato tutto questo e altro ancora. Vorremmo ricordarlo, però, anche come persona giusta e generosa.
Con distacco garbato, non si è mai sottratto a regalare un consiglio, un indirizzo, un chiarimento a quanti, fino all’ultimo, si sono rivolti a lui. Il suo apporto prezioso, per noi, consiglieri dell’Ordine del Lazio, che per quasi un decennio ci siamo occupati di Formazione, non è mai venuto meno.
La sua partecipazione ai corsi realizzati nei grandi teatri di Roma, con centinaia di colleghi, e, soprattutto, alle lezioni per preparare praticanti e freelance agli esami di abilitazione professionale, ha lasciato un segno anche tra i giovani. E tanti, in queste ore, chiamano per confidare tristezza, per chiedere di lui.
Lepri non prendeva mai sottogamba il suo impegno di formatore. Avrebbe potuto parlare a lungo di ogni argomento riguardasse il giornalismo. Eppure, prima di farlo, in lunghe passeggiate intorna al piazzale delle Muse, voleva sapere a chi fosse rivolto il suo intervento e, soprattutto, aveva bisogno di circoscrivere con puntualità il merito delle sue riflessioni. Nei corsi preparatori agli esami di Stato, apriva con noi la settimana di lezioni, insieme a un giovane fresco di abilitazione professionale: erano due, tra i tanti testimoni, di questo nostro lavoro che Lepri sapeva bene essere entrato in una crisi profonda. Per questo, negli ultimi anni, amava intrattenersi sul tema del “passaggio dall’analogico al digitale”. Il suo ragionamento, però, era sempre condotto sul filo della speranza, “forti – ripeteva – della capacità nostra di capire per far capire agli altri”.
Gli avevo chiesto mesi fa di presentare un libro e lui, come sempre, non si era sottratto. A rileggere ora le sue riflessioni, tra le ultime da lui lasciate per il pubblico, si ha contezza della sua capacità di sintesi, frutto di una lucidità di analisi – nella cronaca e nella storia – che ha accompagnato, fino all’ultimo, la sua vita lunga e generosa. (giornalistitalia.it)
Carlo Picozza
La prefazione di Sergio Lepri al libro
di Carlo Picozza, Fausto Raso e Santo Strati
“S.O.S. scrittura. Primo soccorso linguistico”
(Media&Books, 2020, pagine 304, euro 18)
«Per cominciare questo libro conviene ricordare com’è nato in Italia, dopo la fine della guerra, un giornalismo finalmente libero e responsabile; ed è giusto che Carlo Picozza lo proponga a me, che giornalista sono diventato proprio allora, nel 1945.
Gli ultimi anni Quaranta e i primi anni Cinquanta furono anni eroici per la nostra professione. Giornali nuovi e giornali rinnovati nascevano via via, i vecchi giornalisti del passato regime erano scomparsi e bisognava che qualcuno si impegnasse a scrivere per lettori che volevano sapere e conoscere. Ci pensammo noi, giovani fra i venti e i trenta, pieni di voglia di fare in un mondo da ricostruire.
 Molti di noi provenivano dalla stampa clandestina, la maggior parte aveva dietro di sé qualche anno di insegnamento, tutti vedevano nel giornalismo un modo per contribuire più validamente al processo di riassetto, morale e materiale, del paese; un mezzo per consolidare gli istituti democratici appena riconquistati e per garantire il pluralismo in cui si esprimeva il neonato sistema politico. Il giornalismo come servizio; il giornalismo come passione civile.
Molti di noi provenivano dalla stampa clandestina, la maggior parte aveva dietro di sé qualche anno di insegnamento, tutti vedevano nel giornalismo un modo per contribuire più validamente al processo di riassetto, morale e materiale, del paese; un mezzo per consolidare gli istituti democratici appena riconquistati e per garantire il pluralismo in cui si esprimeva il neonato sistema politico. Il giornalismo come servizio; il giornalismo come passione civile.
Anni duri, in un Paese distrutto nelle case, nei beni, nelle persone. Anni duri, ma anche belli, perché pieni di progetti e di attese. La gente vedeva nella stampa, finalmente libera, il segno concreto della democrazia. Voleva sapere quanti etti di farina o quanti decilitri di olio la carta annonaria del razionamento avrebbe concesso in settimana; quando sarebbe tornata l’acqua, la luce, il gas, i tram e i treni; ma voleva anche conoscere i programmi proposti dai nuovi partiti politici, fino allora ignoti; e voleva conoscere le ideologie di cui solo i vecchi sapevano parlare. Socialismo, liberalismo, comunismo creavano un immaginario collettivo carico di meravigliose palingenesi.
Ecco perché decidemmo di fare i giornalisti. Vedevamo nel giornalismo uno strumento per dare ai cittadini le informazioni utili a governare meglio la propria giornata e a migliorare la qualità della vita e, insieme, ad allargare il proprio patrimonio di conoscenze. Chi più sa, più è libero. Insomma il giornalismo come contributo alla crescita civile della società.
Professionalmente eravamo tutti autodidatti. Giorno dopo giorno, il lavoro ci fece imparare tante cose. La più importante è che scoprimmo i lettori, cioè scoprimmo che il nostro compito era non di scrivere per noi e fra noi, ma di farci capire da chi ci leggeva; e quelli che ci leggevano – ci accorgemmo – non erano tutti di alto ed eguale livello culturale. Conclusione: colti o meno colti, tutti avevano il diritto di essere informati e noi giornalisti avevamo il dovere di informarli.
Il problema non era solo nella raccolta delle informazioni, nel controllo delle fonti, nell’analisi e nell’attribuzione dei contenuti, cioè il rispetto delle finalità istituzionali della nostra professione. Il problema era anche e soprattutto nel linguaggio, e per linguaggio era da intendersi sia la grammatica, sia la sintassi, sia il vocabolario, in un paese che, almeno allora, era in buona parte bilingue e in cui l’italiano era la seconda lingua.
Scoprimmo infine che la professione che avevamo scelta aveva, sì, delle grosse responsabilità nel processo di sviluppo della società, ma aveva anche il privilegio di assicurare la correttezza della lingua scritta e parlata. Anche la punteggiatura, anche le iniziali maiuscole o minuscole, anche l’accentazione, anche l’uso non improprio delle virgolette, anche la giustezza dei capoversi, anche la posizione delle parole nella frase.
Che bravi i giornalisti che rispettano queste regole. Oltretutto viviamo in un paese dove l’analfabetismo reale è al 2.6 per cento, ma l’alfabetismo funzionale fra i 16 e i 65 anni è del 28». (giornalistitalia.it)
Sergio Lepri












 CONVENZIONI
CONVENZIONI